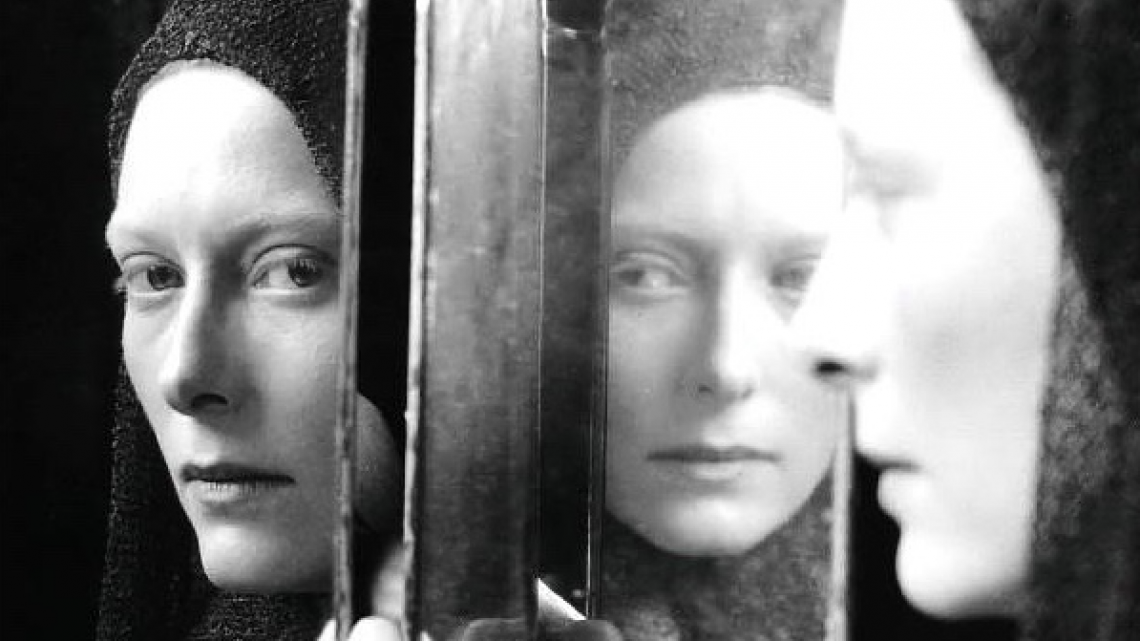
Riflessioni di Savater sopra la nozione di malattia mentale e le relative sue concezioni (prima parte) – di Piernicola Marasco
Non è certo comune – né mi stupirei che appaia ad alcuno stravagante – che tra la bibliografia consigliata per un corso di “Psicologia dinamica” o di “Dinamica delle relazioni familiari” si rinvenga un testo del cui autore il nome non appare tra i cultori delle discipline psicologiche. La prima impressione di stupefacente stravaganza si attutisce in chi, aprendo il testo consigliato, Etica come amor proprio, scopre che l’autore, il filosofo basco Fernando Savater, vi ha inserito un saggio dedicato al tema della malattia mentale, dal titolo Malattia mentale o malattia morale? Ma la prima impressione, benché attenuata, credo permanga di fronte alla constatazione che l’argomento “malattia”, così specifico nella sua tradizionale impronta tecnico – scientifica, sia inserito tra tematiche relative ad un settore, altrettanto specifico ma diversamente caratterizzato, che è quello dell’etica. «Malattia morale»? Permane, inoltre, inaudito che non solo la malattia mentale, ma la stessa etica siano accostate a quell’aspetto particolare della vita umana che in genere si indica con “amor proprio”; termine, tra l’altro, adoperato il più spesso in un’accezione prevalentemente negativa. Eppure, ritengo che proprio questi inusuali accostamenti – che cercherò di spiegare e dimostrare – stiano a fondamento dell’originalità del pensiero dell’autore; così come resto convinto che più di uno spunto delle tante argomentazioni, che Savater dipana nel testo, meriti una riflessione da parte di coloro che condividono un qualche interesse per la psicologia.
I, 1 – La prima delle considerazioni che Savater sviluppa è se il modello interpretativo della malattia adottato dalle scienze mediche – che è stato così fecondo di buoni risultati – sia trasferibile all’universo dei disagi psichici: se, tanto delle sofferenze fisiche quanto delle mentali, si possa dire indifferentemente che si tratti di uno stesso genere di malattia. Nelle discipline mediche la nozione di malattia si costruisce attorno a determinate corrispondenze tra un circostanziato quadro clinico, una sindrome – un insieme di sintomi che nella loro associazione tendono a ripetersi con una certa costanza –, e tre altri diversi livelli di osservazione: un quadro patogenetico, ovvero un’ipotesi sulla genesi dei sintomi, impiantati su una stessa condizione di base – in parte interpretabili come espressione diretta dell’esistenza di una disfunzione, in parte come reazione ad essa nel tentativo di ristabilire un equilibrio perduto-; un quadro anatomopatologico, che individua e collega i due piani precedenti, con la rigidità che è propria di una relazione causa ed effetto, la causa imputata a un danno accertato di un organo; infine, un quadro eziologico, relativo agli agenti – le cosiddette noxae patogene -, che hanno procurato e sostengono danno o disfunzione. Quando gli studi medici sono in grado di avanzare un’ipotesi che ammetta una rigida saldatura tra i suddetti quattro livelli, disponiamo di una saturazione della nozione di malattia, con la quale crediamo di rappresentare fedelmente un dato di realtà.
Questo modello teorico di malattia – si domanda Savater – ha senso trasferirlo alla dimensione psichica? Con quale legittimità la si esporta dalla dimensione biologica e la si impone alla dimensione dello psichico? Al filosofo l’operazione – che resta valida solo nelle malattie cosiddette neurologiche, una per tutte, l’epilessia – prima che poco fruttuosa, si rende impraticabile. Non sfugge, a chi getta un’occhiata anche solo di sfuggita al manuale delle malattie mentali che va sotto il nome di DSM, che le categorie, che il manuale adotta per distinguere l’una dall’altra le tante situazioni di disagio psichico, presuppongono sempre «qualcosa di deplorevole o riprovevole». Osserva, inoltre, che gli stati d’animo, i pensieri, le fantasie e i comportamenti connotati come patologici «sono troppo vari per non insospettire: a volte si chiama in causa la frustrazione e la sofferenza dell’individuo, altre volte l’improduttività sociale, altre lo scandalo», che le condotte indicate suscitano, e infine, «la messa in discussione di certe istituzioni considerate di pubblica utilità».[1]
Due sono le considerazioni che Savater fa attorno a questa osservazione. La prima riguarda la natura degli eventuali accadimenti che costituiscono oggetto del presupposto giudizio negativo da parte del DSM e che la psichiatria si incaricherebbe di«contrastare e correggere».Quelli, cioè, che nella concezione biologica della malattia potremmo indicare come sintomi, appaiono, se considerati nella sfera psico-sociale da cui traggono origine e in cui si manifestano, estremamente variabili: ora fanno riferimento a vissuti inusuali, ora a condotte che non trovano accettazione nel giudizio condiviso, ora paiono contraddire il cosiddetto senso comune. Un ragazzo nella sua frequenza in un’aula scolastica fa fatica a starsene seduto al banco per l’intera mattinata; si muove di continuo e al ragazzo risulta pressoché impossibile prestare attenzione a quanto i professori dalla cattedra comunicano alla classe intera. È chiaro che questo ragazzo “fa problema”; anzi, ne solleva più di uno: rende vane le attività dei suoi professori, disturba l quieta organizzazione della classe, pone in crisi la stessa istituzione scolastica e la sua pretesa di garantire a tutti un comune livello di istruzione. Tuttavia, né la condotta agitata esibita dal ragazzo, né lo stato di disattenzione che contraddistingue il suo soggiorno in classe hanno lo statuto del “sintomo”, così come prescritto dalla concezione biologica di malattia: di una febbre, ad esempio, o quello di una colica.
Inoltre, i criteri che si adottano per “giudicare” e concludere che si sia in presenza di «qualcosa di deplorevole o riprovevole» sono così vari – quasi tutti quelli che adoperiamo per criticare o diffamare gli altri – da far sorgere il sospetto che siano chiamati in causa, al posto di criteri di valutazione scientifici e biologici, l’uno o l’altro dei criteri che il senso comune adotta perché ci si possa lamentare delle tante cose che nella vita non corrono per il giusto verso: condotte che, quando non scandalizzano gli altri, almeno li pongono in serio imbarazzo, e che, disattendendo le aspettative altrui, disturbano la routine della vita degli altri. Si prenda ad esempio le condotte che si ritiene afferiscano all’universo della sessualità: quando qualcuno di noi esibisce condotte che non sono riconducibili alla dimensione disegnata dai criteri che sanciscono una sana e buona sessualità – criteri di ordine morale, quindi -, lo si etichetta come perverso, e medici e psicologici iniziano a darsi da fare per costruire la categoria delle perversioni e, per non dare l’idea dell’arbitrario criterio morale della propria inconsapevole scelta, parlano di parafilie. Paradigmatico in questo senso, è il giudizio cosiddetto scientifico espresso fino a poco tempo fa riguardo all’omosessualità, quale condizione che tanto turbava familiari e vicinato e che il vecchio psichiatra o il novello psicoterapeuta si proponevano – alcuni di loro ancora propongono – di guarire. Man mano che – non tanto grazie a Dio, ma alle numerose battaglie sostenute da esponenti della cosiddetta società civile – si è fatta strada nel senso comune una diversa consapevolezza di un’uguaglianza dei diritti estesa anche a chi sia “diverso” – nel caso, la diversità negli orientamenti sessuali – l’omosessualità ha gradatamente perso per strada la sua connotazione patologica. È stata una strada difficile, irta, non ancora completata e che settori della pubblica opinione sono ancora restii ad intraprendere. Ma quello che in proposito preme sottolineare è un aspetto che conferma i ragionamenti di Savater: cioè, che a sospingere nella categoria delle malattie mentali alcuni atteggiamenti ed alcune condotte, così come sono stati necessari a sottrarla all’inclusione tra le malattie, sono in prima istanza fattori valoriali. La storia dell’omosessualità e della sua accettazione da parte del contesto sociale comporta certo anche una revisione della sessualità, ma testimonia che è dipesa, anzi, è stata possibile solo grazie a battaglie combattute in nome dei diritti civili. Siamo guariti, per così dire, dall’omosessualità non per interventi medico psichiatrici o per esserci sottoposti ad una psicoterapia: ci ha guariti una maggior consapevolezza del significato dei cosiddetti diritti civili! Ma le dinamiche che sono intervenute, prima nella derubricazione dell’omosessualità dalla categoria di malattia e quindi, nel ritiro del suo inserimento fra le malattie mentali e le perversioni, e, dopo nella rivalutazione e accettazione dell’omosessualità possono giuocare un’analoga funzione in altri contesti che costituiscono l’universo delle patologie. Numerose sono le persone che, del tutto insoddisfatte della propria vita, se ne lamentano o si rimproverano, ora accusando un avverso destino, ora ritenendosi responsabili del loro insuccesso: l’esistenza pare a loro deprimente. Ognuno di essi, calato nelle proprie convinzioni, persuade sé medesimo, prima degli altri, e coloro che lo circondano dell’insistenza del suo nero e triste umore. Ecco la psichiatria precipitarsi in suo aiuto, dichiarando che “soffre di depressione”; non è la vita a risultare deprimente, come la vivono, sono loro ad essere depressi. Altri, ancora più scontenti dei primi, tentano il suicidio – e qualcuno ci riesce –, e la medicina parla di “condotte suicidarie” e con le buone o con le cattive interviene per impedire l’insano gesto, mentre studia le più varie e possibili strategie per cancellare da una testa “bacata” un’idea così malsana. Il giorno che convenissimo che il suicidio è una delle scelte che un individuo può liberamente esercitare su se stesso, l’idea di mettere fine ai propri giorni cesserebbe di configurarsi come sintomo e i tentativi di suicidio di rientrare nella categoria delle “condotte suicidarie”. Agli psichiatri e agli psicologi non rimarrebbe che interessarsi ad altro.
Provo a riassumere il discorso fin qui svolto: i criteri con i quali il manuale di DSM distingue tra loro le varie forme della sofferenza psichica sono talmente vaghi che, oltre a far fatica a differenziare uno stato di disagio psichico dall’altro, in alcun modo individuano un tratto rigorosamente distintivo tra ciò che è normalità e quanto non lo è. Porto altri esempi, tra quelli suggeriti dallo stesso Savater: chiunque di noi a volte mette – o potrebbe mettere – «in discussione istituzioni considerate di pubblica utilità», ovvero la scuola, così come è congegnata, la figura del preside e del suo ruolo, delle funzioni o delle modalità con cui vengono assolte. Lo stesso può accadere per altre istituzioni: a esser criticato può essere addirittura il parlamento o l’intera classe politica; più spesso è oggetto di critica il governo e qualche deliberazione di quest’ultimo. Ora, qual è il crinale oggettivo seguendo il quale definire “sana” – più che legittima, doverosa anzi – o “malata” un’eventuale contestazione di un’istituzione che si ritiene di pubblica utilità? Parimenti, chiunque di noi può considerarsi o esser considerato “improduttivo” per questo o quell’aspetto; oppure, responsabile di condotte che sollevano in altri risentimenti o sensi di irritazione.
La pur semplice e breve sintesi che ho approntato del discorso di Savater apre la porta ad una successiva considerazione che, seppure scaturisca dalla stessa analisi dei disturbi elencati nel manuale, è di tutt’altro genere. Non riguarda più la possibilità di far distinzione tra ciò che è normale e ciò che non lo è, ma quella relativa, una volta che si è avanzato il sospetto che non tutto scorra normalmente, alla legittimità della classificazione dell’anomalo entro la categoria della malattia mentale. Infatti, l’universo di atteggiamenti e condotte anormali mostra di essere di un genere diverso da quello nel quale rientrano i dolori e i disagi che si lasciano addomesticare dallo schema di malattia che la medicina ha messo a punto.
Rendono diversi gli uni dagli altri due sostanziali differenze che tra loro corrono. La prima: ogni disturbo è definito sulla base di alcuni comportamenti esibiti dai soggetti, dunque, sempre riferiti a «qualcosa che il soggetto fa, e non a cose che gli succedono». Portiamo ad esempio un raffreddore: un virus m’impone la sua “virulenza”, non faccio che starnutire, il corpo è percorso dai brividi della febbre, sono oggettivamente limitato nelle mie condotte ed altre ne devo assumere per guarire (mi metto a letto, mi faccio preparare una buona tazza di latte caldo col miele, mi prendo l’aspirina,). Così commenta Savater: «In altre parole, la malattia sensu stricto è qualcosa che uno ha, mentre la cosiddetta malattia mentale si riferisce sempre ad atteggiamenti e a “modi di agire” (che) … non siamo in grado di adottare o che si adottano” [2] al posto di altri ritenuti più idonei o “maturi”. In un caso si soffre per qualcosa che chi lo patisce“ha”; nell’altra dimensione rientra chi soffre per qualcosa che “fa”. Di un uomo che – nella sua caricatura – approssimativamente vestito, esce di casa indossando un impermeabile, per frequentare i giardinetti o i luoghi scuri dei sottopassaggi, e, come vede una donna che sembra fare al caso suo, all’improvviso si apre le cocche dell’impermeabile e fa mostra dei suoi genitali, si dice che sia un paziente affetto da esibizionismo. Ma se non ci precipitiamo in una definizione che intenda anche interpretare la condotta del “nostro” – mi piace giuocare con l’equivoco che l’assonanza con la parola “mostro” suggerisce –, se, al contrario, intendiamo restare fedeli ad una descrizione dettagliata del “fatto”, l’esibizionista di fatto compie una sequela di atti, cioè, “esibisce” un comportamento, che, seppur si conclude con l’esposizione dei propri genitali, possiede una maggiore complessità della condotta che di norma gli viene attribuita (o riassunta nel contesto di un cosiddetto caso clinico). Se non ci limitiamo a considerare il suo comportamento dall’esterno e a sorprenderlo nel suo compimento – assumendo paradossalmente di fronte all’esibizionista il ruolo di “guardone” -, se abbiamo l’accortezza di calarci nei suoi panni, non è difficile immaginarlo mentre, tra le mura domestiche si prepara una determinata “scena”, che ne alletta la fantasia, e si premura di porla in atto. È vero che decide di uscire di casa con l’intento di allargarsi le falde dell’impermeabile, ma non sa con precisione se tutto andrà come ha fantasticato: l’idea d’esser visto, non dalla donna, dalla quale vuole essere sorpreso nudo e allo stesso tempo sorprendere, ma da altri rattiene il suo gesto. L’intera sequenza di atti che è necessaria a compiere il proprio atto esibizionista avviene nel registro di un “lo faccio o non lo faccio? Esco di casa o no? Esco o no, vestito opportunamente – seminudo coperto dall’immancabile impermeabile – sì da esibire se non con facilità, con rapidità almeno, i genitali? E ogni donna che incontro farà al caso mio, si interroga o, una volta uscito di casa, avrò da scegliere? E in quale situazione specifica e concreta il gesto esibizionista mi è permesso? E, se permesso, mi gratifica, mi soddisfa?”. In fondo tutte alternative che si pone qualsiasi uomo che si appresta ad accostare una donna, a farle la corte. Quando, infine, si è messo in grado di portare a compimento la propria fantasia, la pone in atto con un gesto che mima un fare di soppiatto ai più, in qualche modo di soppiatto a sé medesimo. Ora se, nel restituire la condotta dell’esibizionista, si ha l‘accortezza di non semplificare il suo gesto, come in genere viene restituito dai casi clinici nella loro pretesa di scientificità – il caso clinico fa dell’esibizionista una caricatura –, è del tutto evidente che il suo deprecabile “gesto” non ha gran ché in comune, ad esempio, con lo starnutire o il tossire. Così anche di quella donna che non fa che piangere e lamentarsi di continuo, che esibisce a volte in maniera sfacciata il suo stato d’animo di non saper far nulla o le sue sensazioni di non trovare in sé forza di fare alcunché e si attarda al letto, si dice che ha una depressione. Se anche in questa circostanza, tuttavia, vogliamo stare ai “puri fatti” e si resiste alla tentazione di farne un caso, non è difficile convenire che quella donna, invece di alzarsi dal letto la mattina come facciamo noi e come ci attendiamo da lei, “fa di restare a letto”; che invece di buttarsi nella vita per farne qualcosa, la vita, che le sta davanti, le appare un ostacolo insormontabile. Non è che non fa nulla e non si alza da letto; non fa niente di quello che ci aspettiamo: non è che resta a letto e non affronta la vita, ma sfugge la vita, scarta dalle più comuni aspettative, seguendo una visione del mondo per la quale la vita, che ai più sembra un’occasione di realizzazione o una prova cui cimentarsi, le si propone di fronte a confermarle, pesante e severa, la sua incapacità, di cui accusa inoltre di portare paradossalmente anche la colpa.
La seconda differenza si rivela quando ci si ponga la domanda chi sia “colui che sollecita la terapia”. «Nelle malattie normali è il paziente stesso che chiede aiuto, mentre per quelle psichiche sono di solito gli altri a stabilire tassativamente chi ne ha bisogno, lo voglia o meno […]. O meglio, il malato normale ha un problema che riguarda il corpo, il malato di mente sembra averlo soprattutto con gli altri o con se stesso in quanto essere sociale»[3], per cui il disagio che dà agli altri o che impone al corpo sociale cui partecipa induce ogni altro, che dal disagio è interessato, ad invitare il disturbatore a provvedere, a curarsi. Soffri di un mal di denti – che ti capita tra capo e collo nel corso della notte, e non vedi l’ora che ti passi, così anche puoi evitare la paura del cavadenti -, ma se quel che speri non avviene, non vedi l’ora, fattasi luce, di precipitarti dal dentista. Ti sopravviene un dolore acuto ad un fianco, quella che si chiama una colica e ti sembra di non potere resistere più di tanto e che solo un buon medico può risolvere un dolore così penoso. Non è questo il modo con cui si presenta il dolore psicologico, che, tra l’altro, ha la caratteristica di contagiare i familiari, gli amici, le persone eventualmente presenti alla manifestazione della sua sofferenza, che avvertono in prima persona il bisogno di far ricorso al “dottore”.
Personalmente aggiungerei alle due citate un’altra radicale differenza che passa tra malattia e il disagio esistenziale, che al filosofo basco è sfuggita – a meno che non la consideri una semplice conseguenza della seconda differenza; se anche fosse così, ne rappresenterebbe tuttavia il tratto più distintivo e dunque meritevole d’essere sottolineato. La potremmo definire, mettendola in successione alle precedenti, una terza differenza. L’intervento diagnostico, ma in modo più accentuato quello terapeutico, comporta nel modello tradizionale di malattia una sorta di delega totale al sanitario: di quanto si sostiene può esser portato ad esempio l’intervento operatorio in un contesto chirurgico. Il paziente non è in grado di giudicare l’opportunità o meno dell’intervento – si fida ciecamente del medico –, tanto meno delle modalità chirurgiche da adottare. Eppure, “accetta” il trattamento: addormentato, lascia stendere docilmente il suo corpo sul letto operatorio e, la coscienza anestetizzata lo consegna senza alcuna riserva alle mani salvifiche del chirurgo. Un intervento terapeutico che seguisse questo andamento, che comportasse il genere di rapporto medico paziente sopra descritto, è del tutto improponibile. Per quanto ugualmente distesi, i pazienti non occupano alla stessa maniera il letto operatorio ed il lettino dello psicoanalista. Quello che è incontrovertibile è che oggetto della “malattia” – se vogliamo seguitare a chiamarla così – non sono alterazioni di funzioni fisiologiche da ripristinare, ma atteggiamenti o condotte assunte dal paziente, e che la loro revisione, la loro “guarigione” richiede al paziente un minimo di partecipazione, per non dire che più grande è la sua partecipazione, migliore e più rapido sarà il suo recupero.
Sono i tre generi di differenze a indurre Savater a porsi la domanda retorica: la malattia mentale è davvero una malattia? Potremmo riformulare la domanda nella successiva: se uso la parola malattia per definire tanto la presenza di un cancro o di una pancreatite, quanto quella di una nevrosi, il termine malattia che adopero, ha in un caso e nell’altro lo stesso significato? La risposta è ovvia e negativa: la nozione di malattia si applica al disagio mentale solo per analogia. Così Savater si esprime: «O non è meglio dire che in quest’ultimo caso, e in altre circostanze simili, la si usa per analogia, come quando si dice che l’economia di un paese è malata?».[4] Si soffre di cancro come di nevrosi, ma nella seconda circostanza, se qualcosa può essere definito malato non è né un organo fisico, né una struttura psicologica.
I, 2 – Fino a questo momento ho cercato di riassumere la prima parte del discorso di Savater e di riflettervi su: è la parte del discorso relativa alla contestazione delle concezioni di malattia mentale; ma a questa fa seguito una seconda parte – una sorta di pars construens – nella quale sviluppa il proprio pensiero in proposito.
Nella pars destruens del suo ragionamento critica la concezione che vede nella malattia mentale la conseguenza di un danno patito da una struttura o funzione cerebrale, dal quale il disagio psichico conseguirebbe quale puro e semplice sintomo; di questa impostazione egli critica non tanto la credenza in una dipendenza della vita psichica dall’integrità fisica e neurocerebrale, che è ovvia – senza integrità neurocerebrale la vita psichica si riduce al limite dell’estinzione -, quanto piuttosto sia la sua generalizzazione – lo “psichico” non è altro che attività neurecerebrale –, sia il suo uso a spiegazione unica del disturbo mentale. È indubbio che la dipendenza dello psichico dal biologico è totale – nel senso che, se non si dà il secondo, non si dà del primo alcuna possibilità –, ma ciò non significa che le manifestazioni delle possibilità psichiche siano totalmente riconducibili al biologico. Prima tuttavia di presentare e porre in discussione la pars construens del contributo di Savater ritengo più che opportuno esporre una particolarità del suo discorso che non può risultare priva di significato. Mi riferisco alla frase che Savater riporta a corredo dell’affermazione che la nozione di malattia si applica al disagio mentale solo per analogia, alla stessa stregua di quando di un’economia di un paese in crisi si dice che è malata. Si parla legittimamente di un’applicazione analogica della nozione di malattia non solo nelle circostanze nelle quali ad essere malato non risulta essere un organo fisico, ma nemmeno un’organizzazione, una struttura psicologica. In altre parole, la critica che rivolge alla tradizione psichiatrica di assimilare, ridurre ogni disagio umano al modello della malattia mentale, Savater la estende all’universo psicologico, al cui interno ascoltiamo spesso parlare di una malattia psicogenetica e proporla in contrapposizione alla concezione di malattia organica. Le polemiche tra le parti, frequenti e a volte anche violente, parlano di una differenza tra loro decisamente radicale, che tuttavia, ad avviso di Savater, non lo è: la differenza c’è, ma non è completa, assoluta, in quanto entrambi i contendenti condividono l’idea che uno stato di sofferenza sempre consegua a un danno o a una disfunzione di strutture interne a chi è vittima della sofferenza. Solo su questa comune idea condivisa è postulata la loro differenza. Se per i sostenitori della malattia organica la dimensione in cui sono supposte la lesioni o le alterazioni delle funzioni è quella neurocerebrale, secondo i sostenitori di una patogenesi psichica della malattia, quanto è leso o disfunzionale rientra nella dimensione psicologica, descritta però in equivalenza se non di un vero e proprio organo, quanto meno in termini di un “apparato”. Resta traccia evidente della compromissione col modello di malattia mentale nell’idea che i cosiddetti sintomi siano espressione o di danni stabilitisi in alcune strutture dell’apparato psichico o di qualche disarticolazione di alcune funzioni psichiche. Sul piano teorico l’universo dello psichico è omologato ad un apparato psicologico a similitudine di un organo, pur di diversa natura. Ma tale residuo di una contaminazione dell’universo psichico da parte del modello di malattia, come la intende la medicina, esercita significativi effetti sull’operatività dello psicologo, che dalle premesse teoriche è sospinto a concepire il sintomo come banale effetto di una lesione interna al sistema “psico”, concependo questa relazione nei termini di una relazione causa ed effetto, e a darsi da fare per rimediare ai “vuoti” – si pensi alla nozione di trauma – o alle disfunzioni dello psichico. Su questo aspetto del pensiero di Savater, così fondamentale per chi pratica attività psicologiche e per chi studia per praticarle, ritorneremo – le dibatteremo – in seguito, dopo aver approfondito le complesse articolazioni del pensiero del filosofo alla luce della pars construens del suo discorso.
I, 3 – Se a chi soffre un disagio mentale non accade niente di quanto predicono le due concezioni sopra accennate, sia quella biologica psichiatrica sia quella psicogenetica, cosa accade a coloro che cadono, metaforicamente, “ammalati”? Se la “malattia” è un termine che si applica alla dimensione mentale solo per analogia, cos’è che “cade malato”? Savater non ha incertezze nell’indicare a oggetto della loro sofferenza un «giuoco comunicativo».
Rientrano dunque nella categoria di coloro che un tempo erano definiti malati di mente gli individui che soffrono di un disturbo che Savater descrive come «una strategia di comunicazione poco fortunata», adottata – scrive – «sia per colpa del contesto in cui il soggetto si muove, sia a causa dei principi applicati dal soggetto stesso».[5] Il disturbo mentale, in altre parole, viene presentato come una frustrazione nel giuoco comunicativo; se vogliamo esser più precisi e riconoscere al paziente una sua attiva, seppur errata, partecipazione, il disagio mentale equivale ad un tentativo frustrato di comunicazione.
Logicamente, per valutare le capacità euristiche della proposta di Savater, è indispensabile comprendere cosa egli intenda con la nozione di giuoco comunicativo e rendersi conto sia del significato ampio che il filosofo dà alla parola comunicazione, sia delle determinate disfunzioni comunicative che egli pone a fondamento del disagio mentale. Non si tratta dunque solo di una generica imperfezione, né di ogni difetto della comunicazione.
Cominciamo col prender in esame il primo problema, l’accezione del termine “comunicazione”. La questione è di una tale complessità che non si dà a risolverla una sola affermazione: ne occorre una lunga serie, numerosa quanto sono i livelli trai quali la questione si dà, di cui il problema è composto. A chiarimento di un primo livello va ricordato che per Savater ogni condotta umana è riconducibile – si parli di azioni vere e proprie o di atti di parola – ad una comunicazione: nessun comportamento si lascia ri/durre al vecchio schema stimolo–reazione, ma lo si può ri/con/durre al giuoco complementare di domanda e risposta: ad un’affermazione rivolta ad un interlocutore dal quale si attende una conferma o una smentita, un assenso o un dissenso. Ciò ammesso, va ricordato che se ogni condotta è, come descritto, un’azione comunicativa, a un secondo livello osserviamo che in essa è implicita un’affermazione che il soggetto fa su di se medesimo. Faccio, dico, penso qualcosa e questo qualcosa che penso o dico o faccio mi esprime: in qualche maniera ogni atto di parola o condotta parla di me; come con le parole che diciamo, siamo, convinti – è spesso così, ma non sempre – di intraprendere una comunicazione, anche le azioni che compiamo comunicano agli altri – molte volte a noi stessi – la nostra identità. Parole e atti – al di là di ciò che concretamente dicono o fanno, degli effetti che producono – possono essere considerati una sorta di dichiarazione agli altri di se medesimi, per cui una condotta risulta composta da una serie di affermazioni di sé da parte del soggetto che la compie. Sostenere il punto di vista precedente – che potremmo sintetizzare come l’inevitabilità dell’implicazione della soggettività di chi compie un’azione – non significa credere che ogni comunicazione umana si esaurisca in un simile livello, negando i significati originari, locutori o illocutori della comunicazione. Significa, anzi, sostenere la sovradeterminazione della comunicazione umana, in base alla quale, la comunicazione è sempre incompleta, imperfetta, dal momento che non può in alcun caso saturare ognuno dei livelli che la compongono: non c’è comunicazione – almeno che non sia di ordine esclusivamente pratico ed economico (quanto costano queste pere? Che autobus conduce alla stazione?) – che si esaurisca senza lasciare alle sue spalle alcun residuo.
Se arrestassimo la nostra analisi sulla comunicazione umana a questo punto, dovremmo smentire Savater: se ogni comunicazione apparisse incompleta e difettosa e contenesse un’affermazione di sé da parte del soggetto, ogni atto comunicativo dovrebbe essere fonte di disagio mentale. Paradossalmente, per salvarci dalla malattia mentale, dovremmo guardarci dal comunicare con gli altri, evitare di stabilire con loro alcuna relazione comunicativa! Ad evitare una simile apparente contraddizione soccorre un approfondimento, un’interpretazione del secondo aspetto del quesito: intendere la dichiarazione del filosofo secondo la quale i difetti della comunicazione che attengono al disagio psichico sono quelli che ostacolano il riconoscimento, da parte degli interlocutori, cui è rivolta l’azione umana, della configurazione di soggetto di chi ha iniziato e conduce a termine l’azione comunicativa. Ad essere chiamate in causa sono quelle forme di comunicazione nelle quale la posta principale in giuoco è rappresentata dalla realtà intercomunicativa che attiene alle affermazioni su di sé: in altre parole, le comunicazioni nelle quali le affermazioni che si fanno valgono principalmente come espressione del soggetto e delle quali quest’ultimo conferma. Ed è comunque qualcosa di molto complicato, perché si danno relazioni in cui le affermazioni su di sé non sono condivise dall’interlocutore, senza che il soggetto si senta messo in discussione e, viceversa, forme di condivisione di tali affermazioni nelle quali, tuttavia, la forma presa dal consenso non soddisfa il soggetto che nemmeno nel consenso si sente del tutto riconosciuto.
Dopo queste premesse, che specificano il luogo in cui nasce e si alimenta la sofferenza psichica, i caratteri oggettivi di quello che chiamiamo il disturbo psichico sarebbero la forma assunta da questa comunicazione infelice, distorta, impotente, che nega dell’interlocutore la sua peculiare soggettività. Quindi, posso ancora parlare di malattia mentale, anche se in senso puramente analogico, se immagino che la sofferenza psichica riguardi le forme di comunicazione nelle quali la posta in giuoco è rappresentata dalle affermazioni che i soggetti fanno su sé stessi. Ovvero, il disagio comunicativo – che è riscontro anche troppo frequente – acquista i tratti di malattia, solo quando investe direttamente e pesantemente la possibilità degli interlocutori di rimanervi presenti come soggetti e quando lo scambio comunicativo procede entro una relazione significativa, a torto o a ragione, “necessaria” al paziente, che finisce col patire l’eventuale dislocazione della propria soggettività: chi parla e intende comunicare, esprimersi nella comunicazione e vedervisi riflesso, e soffre dell’impossibilità a riconoscersi come soggetto.
In questa maniera, Savater sollecita l’attenzione di chi intende venire a capo della sofferenza comunicativa sopra il contesto in cui chi soffre è preso e si muove. Non tuttavia allo scopo di addebitare al contesto la responsabilità della sofferenza, perché alla determinazione del contesto di vita di chi soffre partecipa il soggetto stesso, qualora commetta l’errore di regolare le forme comunicative a modalità che egli trasferisce da alcune infelici forme comunicative in cui si era ritrovato in precedenza. I difetti di comunicazione – scrive Savater – possono essere messi in conto sia al «contesto in cui il soggetto si muove, sia ai […] principi applicati dal soggetto stesso»; dipendono, cioè, tanto «dall’incomprensione ostile dei destinatari del messaggio»,quanto«dalla perdita di autonomia che la sua accettazione positiva comporterebbe per il soggetto».[6]
A volte sono le forme comunicative presenti che non danno modo alcuno agli interlocutori di riconoscersi in una veste umana. A volte, non è tanto la relazione presente ad imbalsamare la comunicazione, ad afferrare in una morsa alienante il soggetto: in qualche caso è la parte che giuocano gli altri attori della comunicazione, quando il volto dell’incomprensione è necessario all’interlocutore per mantenere ruoli di potere e di prestigio; altre volte è lo stesso soggetto a porre la relazione comunicativa in una impasse: o perché giuoca il ruolo di partecipante passivo, secondo esperienze comunicative precedenti, o perché se ne sta chiuso in un mondo proprio, in cui rintanarsi, diffidente, se non chiaramente ostile, verso ogni interlocutore; oppure perché assume atteggiamenti camaleontici, disposizioni adattive ed imitative che evitano qualunque tensione tra gli interlocutori, assumendo condotte che, annullando il giuoco delle parti, vanificano la comunicazione.
In sintesi, Savater sostiene che il disagio e la sofferenza psichica possono esser accostati analogicamente alla malattia, perché accadono quando “cadono malate” le forme comunicative alle quali determinati individui affidano la funzione di riflessione della propria identità e di messa a punto della propria soggettività. Cioè, la comunicazione può essere definita, oltre che difettosa, come quasi sempre è, anche “malata” quando il difetto riguarda la possibilità concessa ai suoi interlocutori di rimanervi presenti nel ruolo di soggetti, i quali patiscono l’eventuale dislocazione dal piano delle affermazioni e dei riconoscimenti della propria soggettività.
Mi permetto, al fine di corroborare la prospettiva introdotta da Savater, di portare ad esempio una vicenda personale. Frequentavo la quinta elementare – dunque all’età di una diecina di anni – quando sul far della sera mi trovai in compagnia di mia madre a due passi dalla stazione ferroviaria fiorentina di Santa Maria Novella; quando – e le ragioni della mia domanda restano a me ancora oggi sconosciute – chiesi a mia madre: «Mamma che ore sono?». «Che domanda fai – mi rispose – hai proprio sotto gli occhi quell’enorme orologio là», col dito indicando la facciata della stazione. Non sapevo all’epoca dell’esistenza dell’orologio ma, dal momento in cui mia madre lo aveva indicato, l’osservai: ma inutilmente cercai di leggervi l’ora. Per quanti sforzi facessi, non vi riuscivo. Mia madre si rese conto che da lontano ci vedevo poco o niente e un oculista, consultato giorni dopo, confermò che soffrivo di miopia. Il sintomo è la riduzione della vista da lontano e dipende da un’incapacità a vedere nitidamente oggetti posti in lontananza; la patogenesi risale al fatto che raggi luminosi provenienti da oggetti lontani cadono su un piano posto davanti alla retina, in essa generando un’immagine confusa che non si lascia mettere a fuoco; il quadro clinico della malattia si conclude e si comprende pienamente sul piano eziologico, perché del difetto visivo la causa è un’alterazione genetica della forma del bulbo oculare oppure della curvatura della cornea o del cristallino. Un quadro, quello riferito, che si lascia con facilità ricondurre alla nozione di malattia e al corrispondente concetto, e ricondurre in modo soddisfacente se in tempi più recenti si sono trovate molteplici soluzioni terapeutiche alle diverse forme del difetto, quali la sostituzione del cristallino e le cosiddette chirurgie refrattive, che tramite laser modificano la curvatura della cornea. Eppure, questo quadro che ho restituito e che nella sua coerenza sembra completo, completo non è, non esaurisce la complessità di quel che è – ed è stata – la miopia di cui “soffro”. Vi è da aggiungere alcune considerazioni di ordine sociologico. Il difetto di cui soffro si rese palese in conseguenza di un confronto tra le capacità visive mie e quelle di mia madre. Se per un caso mia madre non avesse letto bene la sfera luminosa di quel benedetto orologio, se si fosse trovata nelle mie stesse condizioni, incapace di leggervi le ore segnate sull’orologio della stazione, senza sapere, come non lo sapevo io, di essere miope, oggi non saprei che per veder meglio posso ricorrere agli occhiali, di cui mi servo da quando ero nella quinta elementare. Si accede al riconoscere uno stato di malattia attraverso una relazione significativa come è quella che lega un figlio alla madre e viceversa. All’epoca non c’era niente altro da fare, che, esaurita la diagnosi, inforcare un paio di occhiali. Oggi un bambino di dieci anni, che si ritrovasse e vivere la mia esperienza, si ritroverebbe in uno stato di malattia diverso, sia sul piano diagnostico, che è oggi arricchito da una distinzione di tre o quattro diverse forme di miopia, sia su quello terapeutico, che mettono il piccolo in condizione di non ricorrere agli occhiali. Le condizioni sociali, assieme alla vita dei piccoli miopi, ha trasformato la stessa malattia.
Ma le vicende della mia miopia e della relazione con mia madre introducono un altro problema, che col precedente condivide la condizione di partenza: che mia madre ed io non vedessimo le cose alla stessa maniera. Ero ben piccolo e già sapevo che mia madre, per le sue convinzioni religiose, certo, ma anche per chissà quali altre ragioni, passava parte del proprio tempo in cosiddette opere benefiche: mi era stato detto che era stata crocerossina durante la guerra e dopo seguitava “a far del bene”, come si è soliti dire, e come testimoniava il fatto che ogni venerdì pomeriggio e i sabati mattina, uscita, si tratteneva a lungo fuori di casa. Qualcosa di più delle attività materne venni a sapere da adolescente,quando mi invitò a prender parte alle sue pratiche: venni così a conoscere che ogni venerdì sera si riuniva presso la parrocchia con altre “consorelle” – erano cinque, non più di sei, e tra loro così si chiamavano – che esaminavano situazioni delicate in cui versavano alcune persone “bisognose” – le chiamavano così – e decidevano chi aiutare e in qual maniera: valutati i casi e fatte le scelte nel pomeriggio del venerdì, la mattina del sabato qualcuno del gruppo a turno portava a casa del beneficato il genere di aiuto che era stato deciso. Capitò anche il turno mio di metter piede in piccole abitazioni disadorne, veri e propri abitacoli, dove sopravvivevano le persone alle quali portavo quel minimo di aiuto che m’ere consentito e a volte consisteva in un chilo di pane e un litro di latte. Si aprì una finestra sul mondo, del quale fino ad allora non sospettavo l’esistenza; mi fu concessa un’esperienza che oggi valuto di grande importanza per la mia formazione – e di cui son grato a mia madre -, ma che indiscutibilmente al tempo fu per me fonte di sconcerto e turbamento. Mi si spalancarono miserie della cui esistenza mai avevo sentito parlare e di cui non avevo la minima idea e che per il loro grado, mi parvero – sono ancora di questo avviso – incredibili e inammissibili. Quanto mi risultava penoso che, durante gli incontri che facevo, venissi ringraziato una, due, tre volte – non si finiva mai di ripetermi “grazie”; le espressioni a me rivolte a sottolineare una mia supposta bontà a me suonavano dichiarazioni che quel litro e quel chilo che avevo portato fossero per chi le riceveva una zattera per restare a galla sull’onda della vita, per sopravvivere qualche giorno di più. Quando comunicai a mia madre i turbamenti che davo per scontato che lei, che mi aveva portato per mano a simili esperienze, avrebbe condiviso, ebbi una sorpresa: non furono compresi. Lei il disagio mio non lo avvertiva; l’attività benefica alla quale si dedicava non la turbava, anzi, a me dava l’impressione che l’attività che svolgeva la gratificasse: vedeva, considerava quelle “miserie” di realtà alle quali si dedicava in una maniera che non riuscivo assolutamente a comprendere. Ne parlammo a lungo e convenimmo che per lei la miseria esiste e che non c’è modo di porvi rimedio, ma solo di provvedere a soccorrerla, a venirle in aiuto: cos’altro fare se non dare una mano a chi cade in miseria, per quel che si può! Quanto quel che a lei si presentava scontato e “dovuto” a me pareva poco, insufficiente e mi affaticavo a trovare un possibile altro modo di affrontare la miseria che c’è nel mondo: un’altra maniera che non si arresta al “portare aiuto ai bisognosi”, ma presume di sottrarli a una vita che non soddisfa un minimo standard di bisogni. Mia madre è oggi una persona anziana, che avverto mio dovere assistere, e io non sono più l’adolescente dell’epoca. Non sono riuscito a convincere lei della bontà delle mie idee, né lei me delle sue; anni dopo l’accadimento descritto, seguitiamo a nutrire ognuno il proprio punto di vista. Posso accostare, porre a confronto questa diversità di opinioni sulla miseria sociale con le due “visioni” che divisero me da mia madre di fronte all’orologio della stazione di Firenze? Dire che in entrambe le circostanze cadono in giuoco due modi diversi di vedere le cose e porsi la questione di quale dei due vede distorte le cose, perché le sue ragioni cascano fuori da una presupposta retina mentale o psicologica che sia? Nessuno certo può addebitare i modi diversi di valutare le miserie umane a difetti dell’occhio; più d’uno tuttavia si lascia convincere che qualcosa di analogo ad una retina soffra in qualche parte del nostro cervello. Ma potremmo ricondurre la diversità tra me a mia madre a qualcosa che avviene nei nostri rispettivi cervelli, come se diverse curvature convogliassero le immagini del mondo verso inappropriati nuclei cerebrali? E’ plausibile ritenere che quello che fa la differenza che passa tra madre e figlio e madre, risieda in quel che si vede? Certo, quando non riesco a vedere – e mia madre sì – la posizione che nel quadrante dell’orologio hanno le due frecce – l’una che indica le ore e l’altra i minuti -, in giuoco cade la capacità di un visione oculare. Ma già quando, viste e riconosciute le posizioni delle frecce, passo a decodificare l‘ora che segnalano e a ricordarmi cosa l’ora indicata comporti per me, cosa di conseguenza mi solleciti a fare, perde interesse cosa il mio occhio veda. Ciò che l’orologio segna non ha più a che fare col solo occhio, ma con una scansione convenzionale del tempo e con quanto attorno a questo “tempo” organizza la vita quotidiana. Ancora più evidente è che le considerazioni circa le miserie umane conseguono a rappresentazioni del mondo intero. Non avrebbe senso che nel dialogo con mia madre qualche psicologo intervenisse o decretando che è mia madre che non vede bene, perché nevrotica o a me addebitando l’irresponsabilità del dissidio per riconoscermi vittima di un’esaltazione utopica. Si può credere che le due suddette interpretazioni psicodinamiche – poco importa se l’una o l’altra – sarebbero state in grado di migliorare la relazione con mia madre? Forse, ma affrontando il rischio che l’avrebbero potuta peggiorare o romperla definitivamente! Mia madre è ancora viva, ha sulle spalle un buon numero di anni e nell’aiutarla e farle compagnia, come a ripagarla ai sacrifici che lei fece per me quando ero piccolo, i modi di confrontarci con la povertà ancora ci dividono: marcano le differenze che qualificano il nostro rapporto e in questo rapporto i tratti distintivi dell’una e dall’altro, ciò che distingue la madre dal figlio e il figlio dalla madre.
Note:
[1] F. Savater, Etica come amor proprio, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 263.
[2] ibidem., p. 264
[3]Ibid., p. 264.
[4]Ibid., p. 265.
[5]Ibid., p. 268.
[6]Ibidem., p. 268