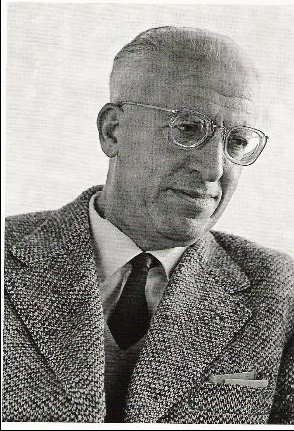
L’utopia della terza via. La lezione politica della psicoanalisi – di Roberto Finelli
- Sul « liberalsocialismo» di Guido Calogero
«Égaliberté» è il neologismo che negli ultimi anni il filosofo francese Étienne Balibar ha coniato per illustrare una configurazione futura possibile della società e della politica, adeguata alla estenuazione delle grandi teorie socio-politiche della modernità, quali il liberalismo da un lato e il comunismo dall’altro. Il neologismo, costruito secondo la crasi dei due termini égalité e liberté, e proposto non caso per la prima volta dall’autore nel 1989 durante la celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese[1], vuole indicare la necessità di pensare una nuova forma di civilizzazione basata sulla compresenza e coalescenza dei due valori che, par excellence, hanno contraddistinto e radicalmente contrapposto, per almeno tutto l’800 e il ‘900, la forma socio-politico ispirata alla libertà e quella ispirata, di contro, all’eguaglianza. Giacchè ora si tratterebbe di pensare una nuova modalità di socializzazione, economica e giuridico-politica, in cui i diritti liberali della persona, o meglio dell’homme (quali diritti all’habeas corpus, alla libertà di pensiero, di associazione, di impresa, di proprietà privata, etc.) dovrebbero poter essere realizzati in quanto e attraverso i diritti del cittadino (citoyen), ossia i diritti che realizzano un’eguaglianza di godimento dei beni e delle opportunità della vita, senza differenza alcuna di genere, di ceto, di religione, di identità etnica, tra i componenti di una comunità.
Coniugare insieme – ma in modo tale che l’uno sia condizione intrinseca dell’esistenza dell’altro – questi due valori, aggiungiamo noi, significa porre fine a un segmento prolungato di storia della modernità nella quale libertà ha significato l’autonomia, in senso kantiano, da ogni fonte di eteronomia e da ogni sopravalutazione del pubblico, che non vedesse in quest’ultimo null’altro che la regolazione delle libertà private. E nella quale, all’opposto, eguaglianza ha significato la valorizzazione, simmetricamente monoculturale, del «pubblico» e del «comune» di contro ad ogni possibile coniugazione del «privato», assunto rigorosamente, nella prospettiva comunista, come mero disvalore.
Solo un profondo ripensamento e una nuova definizione di ciò che ha da essere pubblico e, insieme, di ciò che ha da essere privato, o meglio, solo una diversa relazionalità, che sciolga questi estremi dall’opposizione e li fecondi seconda una sintesi, che una volta avremmo chiamato dialettica, può essere il compito antropologico e socio-culturale di una umanità futura e il contenuto più autentico di una filosofia ad/venire.
Tale proposta, quanto mai originale, del filosofo francese, non ha potuto non richiamare alla mia memoria un episodio della storia filosofica e politica d’Italia profondamente connessa con la questione della mediazione dei due valori, di cui s’è appena detto. Mi riferisco alla teorizzazione del «liberalsocialismo» fatta da Guido Calogero durante gli anni ’30 e ’40 e deposta nella sua forma più esplicita nel Primo Manifesto del liberalsocialismo (1940)[2]: teorizzazione, accompagnata, com’è noto, da una forte azione di resistenza al fascismo che condusse il grande studioso romano di filosofia eleatica ed aristotelica prima al confino e poi nelle galere del regime fino alla Liberazione.
Orbene ciò che qui interessa ricordare è l’aspra polemica che durante quegli anni drammatici ebbe a svilupparsi tra il Calogero, allora ancora relativamente giovane, e il più maturo e ben più autorevole Benedetto Croce. Giacchè Croce ebbe da subito a tacciare la proposta calogeriana di mediazione tra liberalismo e socialismo di essere un «ircocervo» – ossia una bestia immaginaria (hircus=capro e cervo) – visto che pretendeva di mettere insieme due tradizioni di valori e di civiltà, in realtà incompatibili l’una con l’altra. Per il filosofo napoletano infatti il principio supremo della sua filosofia dello spirito e della sua religione civile era la libertà, ossia il darsi eterno e intramontabile dell’autonomia dell’atto spirituale in qualsiasi forma dell’esperienza umana individuale (ovvero l’affermarsi necessario, in ogni distinto crociano, del valore sul disvalore), con la conseguenza che misure sociali e politiche di eguaglianza rientravano solo nell’accidente del possibile e nell’opportunità o meno dei diversi casi empirici, senza poter assurgere alla pretesa di costituire un valore ontologico e antropologico pari a quello, eterno e inconcusso, della libertà. Qui basti dire che la risposta di Calogero, di fronte a un’accusa così aspra e liquidatoria, si sintetizzò in una rimarchevole riflessione, di natura solo apparentemente grammaticale quanto invece intrinsecamente teoretica. Ossia che la libertà interiore, per ciascuno di esprimere e realizzare se stesso, non poteva prescindere dalla libertà esteriore di poter godere di beni e strumenti indispensabili a quella realizzazione, pena la possibilità di ridurre quella prima libertà solo a diritto astratto e vuoto, e che dunque, di contro a tentativi di sincretismo, che pure erano stati pensati nella storia moderna, come «liberalismo sociale» o, viceversa, «socialismo liberale», andava rivendicata non la giustapposizione, conservatrice dell’antica distinzione tra le opposte concezione, ma la sintesi, come genesi teorica e pratica di forme di vita mai finora sperimentate e organizzate.
«Nell’uso di queste locuzioni binarie [liberalismo sociale o socialismo liberale], in cui c’è un sostantivo e un aggettivo, un genux proximum e una differentia specifica, – scriveva Calogero – conviene osservare il criterio di designare col sostantivo l’esperienza ideologica originaria e con l’aggettivo quella a cui si cercò di avvicinarsi o che si volle far valere come momento di correzione o di integrazione della prima: e lasciare invece il termine unitario di ‘liberalsocialismo’ (o anche di ‘socialliberalismo’, se contro di esso non intervenisse l’eufonia) per designare sia le dottrine meno legate ormai all’uno o all’altro dei due punti di partenza e quindi meglio esprimenti una nuova e autonoma visione d’insieme, sia, e soprattutto, il complesso generale di tutte queste teorie e aspirazioni e correnti politiche, variamente miranti a superare la contrapposizione, e l’endiadi, degli ideali di giustizia e libertà nell’unico ideale della giusta libertà [sott. mia]»[3].
Vale a dire che Guido Calogero era ben consapevole, già allora durante la prima metà del ‘900, quanto la civiltà liberale e la civiltà comunista (almeno del comunismo realizzato) fossero forme di convivenza sociale ormai storicamente esaurite per il loro opposto unilateralismo di valori e quanto la necessità del futuro fosse quella di una sintesi che, non lasciando cadere il meglio di quelle due tradizioni etico-politiche, introducesse ad una forma realmente ulteriore di civiltà. Un programma quello calogeriano, che non a caso confluì, come l’elaborazione filosoficamente più raffinata, in quel Partito d’Azione che nell’Italia repubblicana postbellica ebbe a proporsi, appunto, come terza via tra quella democristiana e quella socialcomunista e sul cui ben rapido fallimento si dovrebbe ancora indagare. Problematizzandolo non tanto in termini di storia politica, visto che la divisione del mondo tra blocchi contrapposti e la decisione della realpolitik americana di trovare nella Chiesa cattolica e nella sua organizzazione parrocchiale-politica l’asse della ricostruzione dell’Italia aveva condannato a priori quel tentativo di terza via. Quanto, per quello che qui c’interessa dire, per approfondire le ingenuità, le difficoltà e le mancanze, quanto a visioni dell’essere umano e quanto a concrete organizzazioni dell’economia, che dall’interno indebolivano e insidiavano quel primo, quanto per altro coraggioso, tentativo di aprire un «nuovo passaggio a Nord-ovest»[4].
Soprattutto perché, se è storicamente imprescindibile mettere all’ordine del giorno delle nuove generazioni e dell’intellettualità del futuro il concepimento di un modo nuovo di articolare il nesso individuazione-socializzazione (per esprimere con altre parole la questione della égaliberté), bisogna pur ammettere quanto complesso e difficile sia il pensarlo in concreto, mantenendosi seriamente all’altezza di una sintesi che non abbia da essere una giustapposizione.
- Una «societas»
Ma in questo senso già la tradizione, ormai centenaria, della psicoanalisi, in un fecondo colloquio con l’antropologia filosofica ma anche con la psicologia sociale e le neuroscienze, ci può dare dei contributi preziosi. La teoria e la clinica della psicoanalisi hanno infatti condotto a una singolare complicazione e arricchimento di ciò che, nell’orizzonte di cui stiamo trattando, concerne il polo della libertà. Con la scoperta dell’inconscio – quale che sia la sua natura, che qui non interessa definire – la psicoanalisi ci ha insegnato infatti che libertà, per il soggetto umano, ha da significare affrancamento, il più possibile ampio, non solo da costrizioni e autoritarismi esterni, ma anche da costrizioni e autoritarismi interni. Ossia che la scoperta dell’inconscio ha rivelato una composizione complessa e molteplice dell’intimo dell’essere umano, tale da richiedere la messa a tema di una societas dell’interiorità che si differenzia dalla tradizionale collocazione di ciò che è societas in un ambito propriamente esteriore e intersoggettivo. E che dunque la scoperta di questa verticalità e interiorità antropologica, in quando diversa e peculiare forma di societas, pretende anch’essa, d’obbligo, la sua costituzione e i suoi diritti.
Il diritto essenziale di questo nuovo e sesto continente dell’umano può essere riassunto nel diritto a non aver paura di rimanere soli con se stessi. Nel diritto cioè di ogni esistenza umana di accedere e interloquire con la profondità corporeo-emozionale del proprio sé, la cui presenza è immanente nella sua mente/psiche fin dalla nascita. Questo perché la relazione corpo/mente apre nell’essere umano, fin dall’inizio, un dualismo, un Bino, che costantemente prova ad essere ricondotto all’Uno: con tutte le possibilità di scissioni, rimozioni, forclusioni, proiezioni, censure, repressioni e autoritarisimi che possono darsi in quell’articolazione del Due[5].
Con tale nesso dell’Uno e del Bino la psicoanalisi ci ha procurato, io credo, due acquisizioni fondamentali. La prima, sul piano più specialistico della storia della filosofia, è quella di averci fatto comprendere quanto sia stata regressivo e reazionario lo sfondamento, da parte di Martin Heidegger, del Bino antropologico della psicoanalisi. Che è stato versato dal pensatore di Messkirch nell’abisso, senza fondo, della scissione ontologica di Sein e Dasein, attraverso la riproposizione di una categoria così logora ed arcaica della filosofia quale quella di «Essere». La seconda, di ben maggiore rilievo, è quella di aver messo in grado di concepire un diritto alla libertà interiore del dialogare tra mente e corpo, che appare essere ben diversa dalla libertà liberale che rivendica l’autonomia del pensare e dell’agire dalle costrizioni del mondo esteriore. Perché mentre quest’ultima rimanda a una soggettività la cui capacità e responsabilità di pensiero e di azione è presupposta, la prima rimanda invece a una soggettività che va di volta in volta posta e costruita.
Il punto io credo sia decisivo. Perché se la riflessione filosofica e socio-politica non si apre a questa teorizzazione delle due società – ossia alla diversificazione dei due significati di società, cui il contesto della interior societas necessariamente conduce – essa rischia di bloccarsi in uno sguardo fisso al passato, incapace a formulare le premesse antropologiche di un rinnovato futuro. La libertà di non aver paura di rimanere soli con se stessi, ossia, in altre parole, la possibilità del dialogo tra mente e corpo emozionale, a fronte delle molte diversioni, scorciatoie, dissimulazioni, astrazioni che possono strutturare quel percorso – il diritto insomma di perseguire il più proprio e ineguagliabile progetto di vita in base alle indicazioni del proprio corpo emozionale – deve invece, a mio avviso, rientrare nei droits des homme, nei diritti fondamentali dell’uomo, quale possibilità, non di sopravvivere, bensì di vivere al più alto grado possibile di coincidenza con se stesso.
E’ il diritto di ognuno alla felicità, consistente appunto nel divenire se stessi secondo il quadro delle proprie pulsioni di vita, che la psicoanalisi consegna dunque alla giurisprudenza del futuro, teorizzando che non c’è reale habeas corpus, se accanto alle garanzie della civiltà liberale, che proteggono il corpo fisico dalle costrizioni di una invasione esterna, non vengono accolte e rese oggetto di giurisdizione anche le garanzie che assicurano un corpo psichico, o meglio un corpo somatico-psichico, a vivere secondo la sua più ampia e ricca integrità.
Ma come? Si obietterà da parte di coloro che permangono nel pensare secondo la diarchia di valori antropologici contrapposti e di opposte culture giuridiche. Si vuole rendere oggetto di diritto e di giurisprudenza, ossia di regolazione e normalizzazione pubblica, ciò che per definizione non appartiene al pubblico, perché è proprio di quel foro interiore che per essenza appartiene al privato, in una rigorosa delimitazione e tutela dal pubblico? Si vuole ancora tornare a proporre l’indistinzione contro natura di un ircocervo e ricondurre lo spazio della creatività del singolo al conformismo e all’obbligo di una norma comune?
Ma è ancora la psicoanalisi, aperta ad un sollecito interagire con la filosofia, a rispondere che l’esperienza dell’accesso alla propria interiorità, a ben vedere, non può strutturarsi ed esaurirsi secondo un agire solo privato e infrasogettivo, perchè fin dall’inizio, invece, essa si costruisce secondo una relazionalità costitutiva con l’altro da sé e dunque secondo un piano immanente di socialità e di intersoggettività.
Basti citare in tal senso le geniali intuizioni di Bion e della sua scuola, che, con l’aiuto di quello che noi chiameremo il fattore Kant e il fattore Hegel, ha teorizzato una teoria della mente e del pensiero che non possono venire adeguatamente alla luce se non vengono iscritti in quell’orizzonte relazionale che potremmo chiamare una mente al quadrato. La tesi di fondo infatti di questa corrente della psicoanalisi anglosassone è che la mente fragile e infantile dell’inizio del pensiero non può adeguatamente accogliere le istanze e le forze del proprio mondo pulsionale se non a patto di essere pensata e contenuta da una mente già matura e formata che possa interpretare e riconoscere quell’urgenza emozionale e restituirla, elaborata e mitigata, alla mente in formazione. Vale a dire che senza un riconoscimento hegeliano, nel senso dell’«essere riconosciuta» da un’alterità svolgente funzione materna, non si accende nella soggettività in formazione la capacità di «riconoscersi», cioè di congiungere kantianamente, nella sintesi, sensibilità e intelletto, conoscere e sentire. Perché, senza questo intreccio hegeliano-kantiano dell’esser riconosciuto-riconoscersi, la mente in formazione è incapace di accogliere ed elaborare la propria invasività emozionale e si fa mente scissa ed espulsiva che tratta le proprie emozioni come oggetti noumenici kantiani da lasciare al di fuori del proprio ambito e, per quanto è possibile, espellerli e proiettarli nel mondo esterno.
In sintesi, data la brevità di queste pagine, io credo che questa difficoltà iniziale e fisiologica della gracile mente infantile, che viene superata attraverso relazioni di accudimento sufficientemente buone, sia divenuta, invece, oggi una struttura maggioritaria e dominante della mente matura. E che la situazione psichica ed emotiva generalizzata della nostra epoca, la Stimmung (per concedere qualcosa alla moda del lessico heideggeriano) dei nostri tempi, consista proprio in una incapacità di sentire il proprio sentire, in una forclusione delle emozioni, che consegna l’individuo postmoderno alla patologia disperante dell’«essere indeterminato».
Il mondo greco classico, com’è ben noto, conosceva profondamente il valore dell’horismós, della determinatezza. Invece il mondo postmoderno è strutturato secondo pratiche e istituzioni generalizzate che hanno come loro scopo fondante e imprescindibile, a mio avviso, il divieto a che ognuno si determini come individuo irripetibile e incomparabile con nessun altro e si faccia perciò soggetto. La mente fragile della psicologia infantile è così divenuta tipologia antropologica di massa e ciò che pervade la nuova umanità, soprattutto l’infelicissima umanità del mondo giovanile contemporaneo, è una disposizione d’animo pronta a cadere costantemente nel panico, proprio perché priva di un fondamento emozionale, appunto da cui trarre indicazioni e senso per il proprio vivere. Non si tratta di declino del nome del padre, come taluni vanno da tempo diffondendo, né si tratta di una soggettività volta solo al consumo e al godimento, persa nei petit objets a di lacaniana memoria. Si tratta invece di un «uomo senza qualità», che patisce l’estenuazione del sentire e il vuoto dell’indeterminatezza, ed è perciò pronto a riempire questo vuoto di fondo con qualsiasi pretesto e sollecitazione dell’esteriore (fino al populismo e al razzismo più violenti ed esasperati).
Ma la produzione di un uomo senza qualità, di un essere umano cioè astratto in primo luogo da sé medesimo, è il compito strutturale, accanto alla produzione di profitto, della produzione di capitale. Per chi come me ha trascorso la sua vita di studioso a cercare di chiarire, tra gli altri suoi studi, l’autofraintendimento teorico di cui ha sofferto la figura di Karl Marx, tale connessione intrinseca tra produzione di capitale e produzione dell’uomo senza qualità rimane punto di riferimento costante dell’intendere e dell’agire. Ma, appunto, è necessario lasciar cadere dall’autocoscienza più esplicita e propagandata dello stesso Marx le sue mitologie più canoniche (la presupposizione di una soggettività umana e fabbrile organicamente unitaria e comunitaria, la teoria del materialismo storico, che ne consegue, basata sull’assunzione positivistica della bontà delle forze produttive in contrasto con rapporti privatistici di proprietà e distribuzione, l’inevitabile concludersi della storia nel messianismo della società comunista, per portare alla luce un Marx assai meno prometeico e philosophiegeschichtlich. Il quale può ancora dirci moltissimo sul modo in cui nel cuore della modernità si sia deposto come massimo fattore di realtà non l’operare di individualità umane ma una soggettività an/antropomorfa costituita da una ricchezza astratta e dalla sua ineludibile logica di accumulazione. E di cui a ben vedere le figure umane sono solo, per esprimerci, con le stesse parole del Capitale marxiano, solo Charaktermasken, ovvero figure di superficie e mere incarnazioni di ruoli economici[6]. Per cui, a ben vedere, si può anche accogliere l’acuta definizione proposta da Z. Bauman un ventennio fa dell’umanità contemporanea messa di fronte alla globalizzazione, come «umanità liquida». Ma, assai più profondamente, bisogna io credo ritornare alla lezione di un Marx, in parte paradossalmente ignoto a sé medesimo, che ha indagato e concettualizzato il concetto di Capitale: quale motore di fondo del nostro vivere associato che, accumulando ricchezza astratta in ogni possibile luogo, svuota il mondo del concreto di una sua logica qualitativa di vita, lasciandone solo una silhouette di superficie, che alimenta scenografie isteriche di apparenza e dissimulazione. Vale a dire che una socializzazione attraversata e dominata da una logica di riduzione di ogni forma di vita, sia umana che naturale, all’incremento del quantitativo impedisce per definizione pratiche di individuazione e di soggettivazione, salvo a dover lasciare alle esistenze individuali solo una compensazione apparente di autonomia e di libera agency (visto che non siamo nella schiavitù premoderna quanto invece negli obblighi inevadibili della costituzione democratica moderna)[7].
- Una psicoanalisi generalizzata
Di contro a una forma generalizzata di vita sempre più bloccata nella gabbia d’acciaio di weberiana memoria, una cultura dell’egalibertè, ripensata in termini psicoanalitici e aperta a suggestioni profonde dall’idealismo tedesco, può provarsi a contrapporre il valore di una soggettivazione individuale procurata e mediata da istituzioni sociali del riconoscimento. A promuovere cioè una cultura e una pratica generalizzata del riconoscersi, ciascuno nella propria differente soggettività, promossa e facilitata attraverso istituzioni comuni e pubbliche del riconoscimento. Istituzioni cioè, che dovrebbero mirare, in qualsiasi ambito avessero ad operare (di produzione economica di beni, di fornitura di servizi, dell’intera filiera educativa e scolastica), a produrre accanto all’insieme di oggetti economici, socio-assistenziali, educativi, una soggettività di gruppo, la cui funzione di cura consentisse ad ognuno di parteciparvi e di esprimersi secondo la passione e la dignità del proprio riconoscersi.
A base di tale metaforica estensione della pratica di cura psicoanalitica dagli studi privati ad uno spazio pubblico non potrebbe che esservi, ovviamente, una diversa concezione della ricchezza, rispetto a quella dell’accumulo propria dell’economia capitalistica. Per cui ora «ricchezza», accanto alla disponibilità sempre più ampia di beni materiali e strumentali, verrebbe a significare la liberazione e l’attivazione di un campo enorme di energie psichiche, finora represse o lasciate comunque inoperose nella progettualità del singolo come dell’insieme della società. Per sottolineare, anche qui, che un futuro «liberalsocialismo» potrebbe tornare ad essere concepito (in modo chiaramente ulteriore e nuovo rispetto a quello del secolo scorso) solo attraverso un programma antropologico-politico che coniugasse insieme economia politica ed economia libidica e che si risolvesse a dire addio al Disagio della civiltà di Freud. Ossia a una tesi della psicoanalisi, questa volta da criticare e rifiutare, secondo la quale civilizzazione non potrebbe che significare repressione di istintualità, in una adesione forse eccessiva al dettame nietzscheano della inesorabile contrapposizione tra animalità e ragione, tra natura e cultura, tra potenza dell’origine e decadenza della storia.
Del resto che cosa insegna la devastante esperienza dell’epidemia del coronavirus se non che la fuoriuscita storica dal capitalismo può essere pensata solo con un programma utopico che coniughi insieme ecologia del pianeta ed ecologia della mente? Giacchè, per ritornare a quanto di buono avevano già concepito gli studiosi della Scuola di Francoforte, solo una soggettività umana, che non ha bisogno di praticare autoritarismo e manipolazione in sé medesima, può cessare di praticare dominio e manipolazione verso il mondo esterno, umano e non umano. E, viceversa, solo chi non è iscritto e obbligato in una pratica di sfruttamento e violenza verso il mondo esterno, può avere l’agio e l’opportunità di sviluppare un’attitudine non autoritaria verso il proprio mondo interno.
E’ inutile dire che oggi la realtà della storia ci appare procedere verso un destino profondamente diverso, un destino opposto. Ci avviamo, io credo, verso un nuovo Medioevo malthusiano, che, con il passaggio epocale, dall’egemonia capitalistica americana all’egemonia del capitalismo sotto governance della Cina, vedrà esasperarsi le diseguaglianze, le condizioni del lavoro, lo statuto dei diritti, la lotta per l’accesso ai beni di consumo. Finita la promessa illusoria del Capitale di espandersi economicamente in modo progressivo per tutta l’umanità, vedremo, io credo, con i drammi sempre più devastanti della rovina ecologica, una polarizzazione tra coloro che riusciranno a salire sull’Arca di Noè e coloro che saranno sommersi, economicamente ed ecologicamente. Tanto che è verosimile pensare che l’ideologia dell’infosfera, di un mondo cioè ridotto all’accumulo e al processo pressocchè automatico di informazioni, con il possibile sviluppo di automatismi decisionali legati all’intelligenza artificiale, si costituirà come l’ideologia che accompagnerà e mistificherà la storia del capitalismo futuro secondo un percorso apparente di unificazione di una umanità, costantemente in rete e integrata con i nuovi dispositivi hi-tech.
Ma pure è compito del filosofo costruire e immaginare utopie. Purchè ci si mantenga all’altezza dell’idea filosofica. Di una configurazione di pensiero cioè, che includa in sé, nella coerenza di una configurazione senza contraddizione, il massimo di universalità possibile, il massimo di inclusività possibile del reale. Senza che venga lasciato cadere alcunchè al di fuori, perché quel fuori tornerebbe ad esporre quell’universale alla scissione e all’impotenza del suo contenuto.
La filosofia ha come proprio fine quello di pensare gli universali e, come ci ha sempre detto Hegel, essa o è il luogo di composizione delle scissioni, dei dualismi, delle estremizzazioni, o non è. In tal senso l’idea dell’utopia, che qui si è proposta, è, di nuovo con Kant, idea-limite della storia, non perché la concluda e le ponga fine ma perché la rende viva e sollecita ad avvicinarsi a quel termine infinito.
L’égaliberté di Balibar va dunque a mio avviso riconiugata, e consegnata all’utopia, secondo un programma di ecologia bina, che tenga ben vive entrambe le polarità dell’endiadi, senza trascurare in alcun modo le ragioni dell’oggetto come del pari, e, insieme, le ragioni del soggetto.
Ma pensare i modi concreti di una tale mediazione e intricanza di estremi significa avviare un’operazione culturale e sociale assai complicata, che non potrà non impegnare la fatica e la creatività di intere generazioni future e che soprattutto richiederà l’apertura e l’incontro di tutti i saperi, umanistici e scientifici, capovolgendo il destino delle nuove tecnologie e usandole, non come conferma di una società della conoscenza astratta dall’umano, ma, viceversa, come strumenti straordinari di comunicazione perché l’umanità intera possa dialogare con stessa e con la «memoria del suo futuro».
Note:
[1] É. Balibar, La Proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989-2009, PUF, Paris 2010. Cfr. a tal proposito P. Quintili, La Proposition de l’égaliberté et les Universel d’aujourd’hui, in «Cahiers critiques de philosophie, n. 22, 2020, Hermann-Paris VIII, pp. 105-114.
[2] G. Calogero, Primo manifesto del liberalsocialismo (1940) , in Id., Difesa del liberalsocialismo ed altri saggi, Marzorati, Milano1972, pp. 199-220.
[3] G. Calogero, Difesa del liberalsocialismo ed altri saggi, op. cit., p. 5.
[4] Si consideri in questo senso la critica che appare, in vero, assai debole e qui ancora fortemente condizionata da un impianto crociano, dello stesso Calogero quando si è volto ad affrontare i problemi della teoria economica e del Capitale di Marx, in G. Calogero, Il metodo dell’economia e il marxismo, Introduzione alla lettura di Marx, Latera, Bari 1967.
[5] Sulla teorizzazione dell’essere umano come Uno e Bino cfr. A. B. Ferrari, L’eclissi del corpo. Una ipotesi psicoanalitica, Borla, Roma 1992; A.B. Ferrari-R. Lombardi, Il corpo dell’inconscio, in «Micromega», n.3, 1998, pp. 197-208.
[6] Su questa interpretazione del pensiero di Marx mi permetto di rinviare ai miei testi, Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Bollati Boringhieri, Torino 2004; Un parricidio compiuto. Il confronto finale di Marx con Hegel, Jaca Book, Milano 2015.
[7] Sul capitale come inconscio sociale cfr. il numero di «Altraparola», n.3, 2020, dedicato a questo argomento.