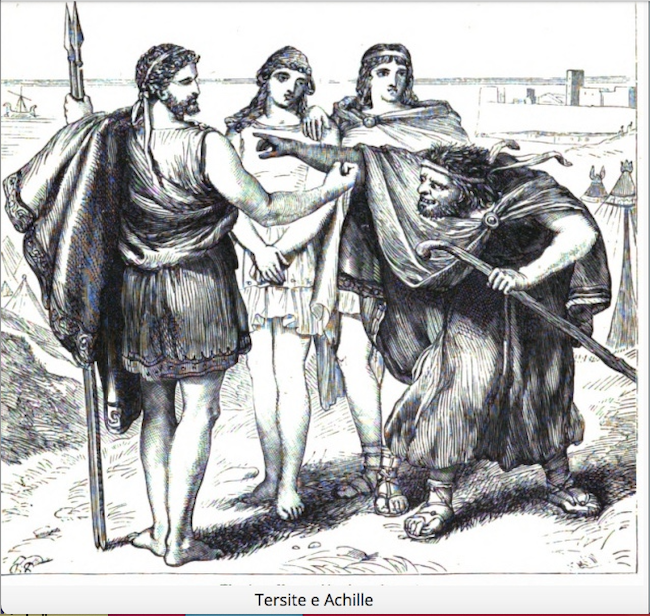
Attorno alla violenza. Appunti sul perdere – di Carlo Perazzo
Ho pena delle stelle
che brillano da tanto tempo,
da tanto tempo…
Ho pena delle stelle.
Non ci sarà una stanchezza
delle cose,
di tutte le cose,
come delle gambe o di un braccio?
Una stanchezza di esistere,
di essere,
solo di essere,
l’esser triste lume o un sorriso…
Non ci sarà dunque,
per le cose che sono,
non la morte, bensì
un’altra specie di fine,
o una grande ragione:
qualcosa così,
come un perdono?
Fernando Pessoa
10.12.1928[1]
Premessa
Questo articolo non vorrebbe avere una tesi da dimostrare. Sono appunti nati dal bisogno di creare un legame tra dinamiche esterne e dinamiche interne, antiche e presenti, personali e collettive. Alcuni passaggi fanno parte di una più ampia riflessione racchiusa in questo testo appena uscito. L’idea di fondo è che ci sia qualcosa che intreccia le molte declinazioni del collasso sociale e politico cui oggi assistiamo e che abbia a che fare con la dimensione della violenza. L’eroismo – in salsa più hollywoodiana che omerica – e la performatività, la paura della perdita, il dispotismo e l’affermazione, come tratti della cultura egemone, sono forse ciò che ci tiene lontani dal concepire la pace e la non-violenza non tanto come buoni comportamenti etico-morali, quanto piuttosto come tratti essenziali, costitutivi della realtà stessa.
Se questa idea può avere un senso, la diffusa violenza strutturale nella quale siamo immersi e che nulla ha a che fare con le forme di conflitto generativo, risulta essere non solo “brutta e cattiva”, ma si configura come una sorta di smarrimento, di allontanamento sempre più radicale dallo sfondo comune a tutte le cose. Può essere utile, leggendo, immaginarsi i volti e le dichiarazioni assurde degli uomini che hanno trascinato il mondo e tutti noi nell’ennesima terribile guerra; ma sarebbe ancor più importante provare a immaginare in qualche modo anche noi stessi, i nostri vicini, colleghi, compagni, nelle nostre vite di tutti i giorni; non solo i massimi sistemi quindi, ma anche i minimi quotidiani, sentendo se non ci sia, per caso, un qualche legame tra le due dimensioni.
Purtroppo il tono del testo è molto affermativo, a sua volta un po’ violento, ma forse per via di quello che già Debord diceva della possibilità di analizzare lo spettacolo: «Analizzando lo spettacolo, si usa in una certa misura il linguaggio dello spettacolare, dal momento che si transita sul terreno metodologico della società che si esprime nello spettacolo»[2]. Lo stesso vale forse per l’analisi della violenza nella società della violenza.
1. Elogio della disabilità
«Non voglio imparare a non avere paura, voglio imparare a tremare»[3]
Quando nel II libro dell’Iliade, Zeus, per mezzo di un sogno ingannevole, spinge Agamennone – comandante dell’esercito acheo – a lanciare la presunta presa finale di Troia, il poema della guerra per eccellenza mostra un personaggio poco conosciuto eppure estremamente significativo: Tersite. Nel mondo eroico della grecità che ancora oggi, seppur in modo superficiale e distorto, abita il nostro immaginario, tra il genio di Ulisse e la forza di Achille, Tersite appare come l’emblema dell’antieroe.
«il più spregevole, fra tutti i venuti all’assedio di Troia.
Aveva le gambe storte, zoppo da un piede, le spalle
ricurve, cadenti sul petto; sopra le spalle
aveva la testa a pera, e ci crescevano radi i capelli»[4].
Non è solo il suo corpo a essere antieroico. Per gli eroi omerici Tersite è colui che pronuncia “parole confuse e inutili”, ostili ai loro progetti. Nonostante ciò, o forse proprio questo, è anche colui che ha il coraggio di opporsi al volere di questi potenti uomini di guerra. Di fronte ad Agamennone, Tersite invoca un ritorno in patria e dice ciò che moltissimi soldati, mandati in guerra a combattere per interessi di altri, direbbero:
«Atride, di che ti lamenti ancora, che vai cercando?
Hai le tende piene di bronzo e molte donne
ci stanno dentro, scelte, che a te noi Achei
come a primo doniamo, quando espugniamo una rocca.
Hai bisogno ancora di oro, che ti porti da Ilio
qualcuno dei Troiani domatori di cavalli, quale riscatto di un figlio
fatto prigioniero da me o da un altro degli Achei,
oppure di una giovane donna, per mescolarti con lei in amore,
da tenertela tu, in privato. Ma non è giusto
che il capo porti alla rovina i figli dei Greci»[5].
Il tentativo di Tersite è in qualche modo diabolico, nel senso etimologico del termine, ovvero di dividere, da “dià-bàllò” (curioso notare anche il diavolo è spesso rappresentato zoppo). Dividere i soldati dai capi, i re dai sudditi, gli eroi dai comuni mortali. E come un povero diavolo egli viene emarginato. Nell’Iliade è Ulisse a punirlo: “non ti azzardare a disputare coi capi”; “non c’è nessuno peggiore di te”; e con lo scettro dorato, simbolo per eccellenza del potere, lo picchia violentemente. Tersite piange, ha paura, si inginocchia attonito e gli altri, soldati ed eroi, ridono. Nessuna ritirata, tutti tornano a combattere, anche se il sogno di Agamennone risulterà mentitore: la guerra non si risolverà in quella battaglia e molti ancora dovranno soffrire.
Tersite: il primo disabile della storia della letteratura. Le parole “debole” e “disabile” hanno la stessa origine: de-hàbilis, senza abilità, che manca di qualcosa. Il debole, lo storpio, mancano indubbiamente dell’interventismo eroico, della competenza guerrafondaia, del successo di una certa giustizia, dell’orgoglio che esige vendetta.
Se nei poemi greci un personaggio così aveva la funzione di far risaltare con ancora più forza l’eroismo dei grandi condottieri, oggi, che quotidianamente vediamo le macerie sporche di sangue e di tristezza che lasciano ovunque coloro che a testa bassa conducono il mondo in una guerra diffusa e perenne, forse Tersite può aiutarci a raccogliere immagini per un controcanto capace di uscire dalla spirale di violenza nella quale vortichiamo.
Ciò che abbiamo definito per decenni “successo”, si rivela in realtà come uno dei nostri maggiori handicap. L’ecosistema si sgretola sotto i colpi di un modello di sviluppo che è stato considerato “di successo”; noi ci sbricioliamo – o ci devitalizziamo murandoci per non sbriciolarci – tritati da una performatività interventista onnipresente; la nostra società implode perché “i competenti” non riescono a concepire nulla al di là del rilancio continuo della vittoria contro il diavolo di turno (il nemico barbaro, il virus, l’ennesima crisi, i trafficanti di esseri umani), in una retorica sempre più vuota e sorda.
Nel collasso del mondo dell’efficienza tecnocratica, la dis-abilità si propone come la luce che entra dalla ferita; è l’invito a guardare la salubrità degli zoppicamenti e dei momenti di balbuzie, la giustezza del nostro “essere meno”, non-funzionare, impallarci, essere stanchi, non sapere, esitare, non essere all’altezza di un mondo che da quella altezza sta precipitando. In un mondo capace solo di guerreggiare, la disabilità è la prima forma di diserzione.
Se la sottrazione non fosse lo scopo, ma il movimento necessario per riprendere contatto con la realtà – debole – delle cose? Se fosse il gesto capace di smaltire il troppo pieno di un mondo che di iperabilismo si è ammalato, che nella maniacalità del fare non trova più un modo per esistere senza distruggere?
2. Intorno I. Appunti dalla finestra
Méden ágan (nulla di troppo)[6]
La guerra non è solo lo scontro bellico tra forze armate, ma è il nostro scheletro sociale, la nostra infrastruttura: come le città ipermoderne che nel tempo di Amazon modificano i propri spazi a favore dei furgoni del consumo prêt-à-porter, l’infrastruttura sociale è diventata per soggetti potenti (o meglio, potenziati), che sanno imporsi, sanno intervenire, essere “sempre in pista”.
È l’esaltazione del principio darwiniano della sopravvivenza del più forte che va ben oltre la sua parziale veridicità biologica e raggiunge la sua esaltazione grazie all’imporsi di un certo modello sociale, economico e politico. Non c’è spazio per una postura incerta, riflessiva, domandante, lenta. Chi va piano, non ha strade pubbliche a disposizione, mentre la violenza gode di corsie preferenziali.
Un modello a maglie strette che incentiva un modo violento di stare al mondo ha imposto strumenti “educativi” coercitivi dai quali è sempre più difficile sfuggire: lavoro competitivo e precario, disgregazione degli spazi collettivi, tempi iperveloci, comunicazione istantanea e continua, distruzione sistematica dell’ambiente vitale, coazione al consumo, omologazione dell’immaginario, vetrinizzazione dell’intimità.
Tutto pare inghiottito nello spettacolo dell’affermazione, forse proprio perché nulla è certo di esistere davvero.
“Loro”, nel vortice ossessivo del potere, esercitano una violenza brutale e allo stesso tempo ipocrita che occulta e maschera se stessa. “Noi”, che ci sentiamo come piccole chiazze di contropotere, riusciamo a incorporare qualcosa di realmente e profondamente diverso?
La filosofia nei licei vive l’eccitazione del “dibattito”: studenti e studentesse, divisi in squadre in un torneo a premi, devono difendere una tesi o il suo contrario, convincendo le giurie di essere dialetticamente più brillanti della squadra avversaria. È eccitante, insegna a ragionare e rispondere in modo rapido e vincente; ma nonostante il codice di condotta in nome del rispetto dell’altro, non può che essere competitivo, performativo, e certamente non dà dignità alla domanda e al tentennamento, alla fragilità: il “non so”, l’emotività e la delicatezza perdono.
L’impressione – certamente parziale – è che le poche persone che cercano di rispondere alla violenza di chi guida la macchina sociale spesso lo facciano con foga e aggressività, immerse in un ruolo predisposto dal gioco stesso e quindi prevedibile; tra l’altro, visto lo squilibrio delle forze in campo, la frustrazione raddoppia quanto risulta evidente un progressivo arretramento generalizzato.
La cooptazione degli elementi sovversivi da parte del “sistema” si sposta dal piano dei contenuti a quello della forma, dell’atteggiamento: come se, di fronte alla persistenza di sacche di resistenza non cooptabili, il mo(n)do capitalista stia però riuscendo a condizionare i modi di “essere resistenti”, riconducendoli alla violenza e alla performatività che esso stesso promuovere per sussistere.
Al di là e al di sotto dello spettacolo ci sono esistenze meravigliose, spesso sofferte e profonde, qualche volta serene e salde, troppo di frequente isolate e puntiformi. Ma l’infrastruttura sociale le rigetta, le espelle come elemento perturbante, non le lascia passare, come biciclette in un mondo di sole autostrade.
Cosa ci spaventa della debolezza?
Per quanto dentro bruci la rabbia dell’ingiustizia e il disgusto per l’ipocrisia divenuta regola, vista la poca efficacia di una logica del risentimento, è forse possibile e utile trovare un modo non-violento di osservare l’intorno con tenerezza, cercando una via verso tutto ciò da cui stiamo fuggendo, a partire da noi stessi, come le pratiche di autocoscienza femminista insegnavano decenni fa. Non sorprendono gli atteggiamenti di uomini despoti che (da decenni) stanno dando fuoco al mondo; piuttosto dovrebbe interrogarci quel che riguarda tutti e tutte noi, che in quel fuoco bruciamo.
Da cosa ci tengono lontani i milioni di festival, di esperti, di articoli, di iniziative, di corsi, tutti accattivanti, splendenti, importanti, in qualche modo vincenti? Non manca l’attivismo, lo studio, le prospettive critiche…eppure qualcosa manca. Ipertrofia e saturazione come risposta alla perdita di un quadro delle cose? Come rilancio del proprio esserci per paura di tutto il non-essere (o esser-altro?) che, come società, soffochiamo dentro? Che questi ritmi non siano sostenibili lo mostra il successo dell’industria del supporto prestazionale che abbiamo inventato: integratori, sostante psicoattive (farmaci inclusi), palestre, motivatori, narcisismo dilagante, e poi ansia e rabbia, rabbia a palate, mescolata alla frustrazione dell’impotenza.
3. Interno I. Appunti allo specchio
«Quando la paura bussa, apri»[7]
Cosa accade se mi fermo? Mi aspetta il crollo, la sparizione o, come in Pessoa, “un’altra specie di fine, o una grande ragione, qualcosa così, come un perdono?” Cosa c’è al di là dell’intervento?
Se, come indicava Marc Bloch, «i fatti storici sono essenzialmente fatti psichici»[8], dobbiamo sostare sulla soglia di queste domande e chiederci che consistenza abbia la trama che lega la “guerra in sé” alla “guerra in me”. L’esaurimento in corso è sia soggettivo che oggettivo, sia socio-antropologico che ecologico: abbiamo bisogno di ponti tra le parti, e gallerie.
La guerra è arrivata dentro di noi? Abbiamo forse introiettato l’interventismo-efficientista e siamo, di conseguenza, terrorizzati da – e quindi violenti con – tutta la nostra stanchezza e titubanza, fisica, psichica e quindi anche politica?
La guerra è in me ogni volta che, spaventato dalla sensazione di vacillamento, lancio bombe sul mio Tersite interno che protesta contro la corsa continua e un po’ maniacale verso le mie aspettative di affermazione. La guerra non è tanto il conflitto naturale tra parti diverse eppure legate di sé, che potrebbe essere generativo, quanto piuttosto quell’atteggiamento che impedisce l’ascolto della parte titubante e dis-abile, non si sofferma a osservare cosa rappresenta e, nell’intuizione spaventosa che si tratti di qualcosa di opposto all’atteggiamento dominante, reagisce aggressivamente con le bastonate di Ulisse.
Come l’ecosistema, anche la dimensione psichica, non conosce l’andamento progressivo cumulativo nel quale un aspetto può crescere all’infinito e dominare autonomamente. L’equilibrio vitale è fatto di espansione e contrazione, esattamente come il respiro che ci accompagna lungo tutta la nostra vita. La dinamica è quella indicata da Luigi Zoja, una «complementarietà circolare tra attività e pensosità, tra maniacalità e depressione, tra estroversione e introversione»[9].
Immaginiamo un teatro in cui vadano in scena molti personaggi che spingono la storia verso differenti direzioni. La stessa Iliade può essere vista come il teatro di una molteplicità di forze in conflitto tra loro; e per quanto ci siano dei vincitori e dei vinti, a questi ultimi viene data voce e risalto, sono riconosciuti tanto da potersene innamorare.
Oggi a teatro va in scena il monologo di un solo personaggio, ormai esausto, barcollante e smanioso, che però tiene dietro le quinte tutte le altre voci.
Lo sbilanciamento verso la posizione maniacale ha come conseguenza un disapprendimento della necessità e del potenziale “depressivo”, inteso come momento di silenzio e attesa, di recupero, di contatto con l’umana debolezza. “Non voglio vederti, non posso sentirti, sparisci”.
Come nella storia taoista che racconta Chandra Livia Candiani nel suo meraviglioso libro sulla meditazione: un uomo ha paura della sua ombra e delle sue impronte, così corre e scappa, ma quelle lo inseguono e lui corre sempre più forte, fino a morire: «egli non capiva che per far scomparire l’ombra bisogna rimanere nell’oscurità, che per far cessare le impronte bisogna rimanere nelle quiete»[10].
Evitare l’incontro con l’emozione difficile, aggredirla o ignorarla, innesca un processo simile ad un’automutilazione: talvolta – fortunatamente – la violenza verso se stessi porta ad una reazione che produce sintomi disabilitanti (nel senso buono del termine, anche se spesso molto dolorosi) e attraverso di essi offre l’occasione di riaprire il dialogo; quando soffriamo, non ce la facciamo più, nonostante il dolore, qualcosa ci sta offrendo l’occasione per integrarci, volerci più bene, volerne di più agli altri. In altri casi, quando siamo più fortificati e non più predisposti alla crepa, la violenza può creare una tabula rasa di ogni voce interna, un dispotismo duro e intransigente, che spesso comporta anche l’incapacità di accogliere le voci esterne, riproducendo la violenza verso il mondo circostante. Questo modo contribuisce a rendere il mondo un posto più violento.
È forse una questione di limite: evitare l’incontro con qualcosa di altro rispetto alla tendenza dominante significa tentare di rimuovere la fine di quella tendenza, rifiutare la perdita di ciò che siamo o pensiamo di essere. Fine, limite e perdita sono forse gli aspetti primari che apprende un essere umano nel suo crescere col mondo, e sono i bersagli privilegiati del nostro tempo guerrafondaio.
Tutta la storia dei riti di iniziazione che per millenni hanno sancito la fine di alcune fasi di vita, di alcuni modi di essere, e l’inizio di altri, parlano di questo. Mentre l’interdipendenza con quella che oggi chiamiamo “natura” educava alla dimensione ciclica dell’esistenza, dove il grano doveva morire per dare nuova vita e così tutto il resto.
A ben vedere, quella che con colpevole sintesi consideriamo la parte “sinistra” del mondo, almeno in Occidente, ha troppo spesso ricacciato tanto i riti quanto una visione animista – o almeno animata – della “natura”, considerati retaggi superstiziosi e religiosi che il “progresso” avrebbe reso superflui.
C’è un modo per non abbandonare il mondo e le sue contraddizioni e allo stesso tempo cercare di non replicare i suoi meccanismi violenti e distruttivi?
C’è spazio e tempo per una politica radicale e non-violenta?
La perdita è forse un ponte tra intorno e interno.
4. Intorno II. Appunti su morte e realtà
«La conquista che vuol ignorare confini si fa ingordigia di acquisizione; l’esistenza che vuole ignorare la morte diventa nevrosi di vita»[11]
Ad ogni modo la rabbia si capisce. Si srotola dinnanzi a noi il tempo della necropolitica. La produzione di morte da parte dell’umano, nel mondo globalizzato, ha raggiunto una pervasività annichilente. La politica asservita ad un meccanismo che ha come primo fine quello di una crescita infinita all’interno di un sistema finito, non può che generare morte, poiché il margine di accumulo si scarica nel principio del massimo sfruttamento possibile.
Nella “repubblica fondata sul lavoro” muoiono di lavoro circa quattro persone al giorno; il bel Mediterraneo azzurro è la rotta più pericolosa al mondo con una media di duemila morti l’anno; il criterio del PIL non conosce dimensione qualitativa e cresce con la produzione di armi, di inquinamento e col consumo di medicine; nonostante le “grandi democrazie”, la ricchezza da anni si sta concentrando mostruosamente in un pugno sempre più ristretto di personaggi.
Forse la produzione di morte è l’altra faccia della fuga dalla morte. Il capitalismo, per evitare la sua fine-morte, ha bisogno di radicalizzare e ampliare lo sfruttamento. La strage, pur variando d’intensità di ambito in ambito, è strutturale. La necropolitica non riguarda solo gli umani, ed eccoci nel pieno della sesta estinzione di massa.
E se il problema del governo violento e mortifero della nostra realtà fosse profondamente legato ad una lettura violenta della realtà stessa?
Se la non-violenza è concepita come una questione esclusivamente etica, allora cadiamo in un tranello, nella misura in cui l’etica è inevitabilmente condizionata dall’idea di realtà che abbiamo. In una realtà immaginata come lotta per la sopravvivenza, la violenza può essere eticamente deplorevole ma tutto sommano nell’ordine naturale delle cose. Ci vuole uno sforzo morale per fuggire e incatenare la violenza che, “per natura”, abbiamo dentro e fuori di noi.
E se invece la non-violenza fosse una questione prima di tutto ontologica e avesse a che fare con la struttura della realtà che abitiamo?
La concezione della “natura” come un oggetto separato da noi e sul quale sperimentare risiede al cuore della scienza moderna. È una lettura della realtà che ha permesso quel fenomeno estremamente potente che chiamiamo rivoluzione scientifica e tutta una serie di conquiste tecniche importantissime, ma non è la Realtà. Quello della scienza moderna è un mondo fatto di partizione e interventismo, dove la ragione è ragione strumentale; è armata poiché deve ottenere qualcosa: ma come ricordava Bateson, “la mappa non è il territorio” e se pretende di esserlo, o se noi non ci preoccupiamo di comprendere la differenza, è un problema, sia di ordine psichico che di ordine politico.
Nell’ecologia profonda di Arne Næss la realtà è un «campo totale relazionale»[12]. Le “cose” sono nodi di una rete che, integrerebbe Raimon Panikkar, ha un “versante opaco” che non ci è dato vedere, possedere o controllare. Si impongono così almeno due limiti: all’individuo chiuso autoreferenziale; alla possibilità di ca(r)pire completamente la realtà. E poi, almeno due conseguenze: violentare uno qualsiasi dei nodi implica un attacco alla rete tutta; la rete dovrebbe offrire un’immagine più collaborativa che competitiva.
Il governo attuale delle cose è violento non solo perché agisce violentemente, ma perché si fonda su un’idea di realtà violata, frantumata. Non è una rete intrecciata la realtà a cui ci hanno educato, ma un mondo diviso di soggetti che calpestano, toccano, usano, oggetti. La categoria di “oggetto”, poi, sfuma facilmente a tutto ciò che non è considerato umano, cosciente, senziente e la storia ci insegna che anche alcuni gruppi umani facilmente finivano (finiscono?) per non essere considerati tali.
La frantumazione diventa così un dato di fatto, non un gesto violento.
A teatro vanno in scena solo monologhi. Lo spettacolo di una realtà interdipendente e sfuggente invece non può concepire alcun monologo: ogni personaggio sarebbe legato inevitabilmente ad altri e, cosa forse più importante, molti di loro resterebbero sconosciuti agli spettatori.
Per questo, diceva ancora Panikkar, la via del disarmo deve passare per un disarmo culturale[13], che è epistemologico, ontologico e antropologico allo stesso tempo. La pace non può più essere pacificazione e silenziamento (che spesso diventa profonda umiliazione e quindi vendetta) del “nemico” di turno, né quella pax romana che si traduce nell’ordine imposto dal vincitore che piace tanto alle prepotenti democrazie occidentali. Non può essere nemmeno solo una questione morale, un “essere buoni e rispettosi” degli altri. C’è qualcosa di più.
La pace, come la rete, è prima di tutto un processo, non uno stato di cose: è il riconoscimento costruttivo e non-violento del conflitto, delle tensioni e delle molteplicità che animano la realtà, al di là di noi.
Per questo sarebbe miope vedere la pace come qualcosa da (im)porre o come qualcosa di esclusivamente umano; piuttosto la si scopre, la si riconosce, la si nutre, rendendoci conto che essa fa già parte della realtà, e in questo senso è ontologica e antropologica, ancor prima di essere una scelta morale.
A partire da una diversa immagine di realtà, sarebbe più semplice concepire il conflitto non come percorso dialettico verso una sintesi risolutiva (la “cosa” finale), ma come “tensione dialogica”[14] (il processo continuo), per noi umani traducibile in una postura di apertura e disponibilità al dialogo, non in termini esclusivamente concettuali e razionali, ma empatici ed esistenziali. Ascoltare la voce dell’altro non solo come parola, ma nel modo in cui risuona in noi.
«La pace è il dialogo, non l’esito oggettivo del dialogo»[15]. Sembra banale, ma tutta la nostra capacità dialettica sembra oggi spazzare via la postura dialogica fatta di ascolto profondo, rendendoci muti e sordi, persino a noi stessi.
5. Indietro. Prima di noi
I tempi di guerra rispolverano il pensiero evoluzionista e le sue risposte “infallibili”: la guerra è naturale perché l’umano è naturalmente violento; siamo eredi della scimmia di 2001: Odissea nello spazio, in cui l’umanizzazione passa per la violenza; condividiamo un antenato con gli scimpanzé che sono noti per la loro aggressività brutale; si dice, e il discorso è chiuso.
Eppure, sempre più spesso, le scienze contemporanee dimostrano quanto la dimensione collaborativa sia stata fondamentale alla co-evoluzione sulla terra[16]. L’antropologo Brian Ferguson, che ha dedicato decenni allo studio della guerra e dell’aggressività, in una ricerca su 426 anni di dati di osservazione di scimpanzé, si sente di poter dire che «la violenza mortale tra gruppi non è un modello di comportamento normale ed evolutivo […], ma una risposta situazionale a una storia locale di interferenze umane»[17].
Nel suo libro Ferguson fa notare che noi umani condividiamo un antenato anche con i bonobo, e pare che nessuno abbia mai visto un bonobo ucciderne un altro. Anche qui, l’autore ci tiene a sottolineare che non è una questione di “essenza”, geni o predisposizione. «I Bonobo non vivono nelle condizioni che penso facciano combattere gli scimpanzé, cioè una scarsità di risorse collegata all’impatto umano. […] E allo stesso tempo, hanno qualcosa che li allontana dalla predisposizione a lottare, ovvero un’organizzazione sociale molto diversa dagli scimpanzé»[18].
Un cucciolo di scimpanzé cresce osservando «un mondo adulto dove i maschi dominano le femmine e le femmine non passano molto tempo con altre femmine. I maschi passano un sacco di tempo con altri maschi, […] e questo li porta a impegnarsi in una competizione di rango secondo il paradigma maschio contro maschio»[19]. Nei bonobo, al contrario, «se un maschio vuole salire nella gerarchia […] deve essere meno aggressivo… perché la struttura della società è basata su una scala a due sessi»[20]. La differenza centrale dei due sistemi sta nel rapporto tra i generi e nel conseguente modello educativo.
Ferguson sostiene anche che ci siano molteplici prove del fatto che la guerra tra umani non sia esistita per millenni. I primi segni di guerra appaiono intorno al 10.000 a. C.. In diverse zone del mondo non si trovano tracce di guerra anche fino a circa duemila anni fa. «Gli indicatori della guerra appaiono in momenti diversi in luoghi diversi. E, una volta iniziata la guerra in un luogo, a volte scompariva per un po’, anche se questo andamento non è quello più frequente. Spesso la guerra si diffondeva e cambiava nel tempo al variare dei sistemi politici»[21].
C’è chi sostiene che le società matriarcali non utilizzassero lo strumento della guerra; chi parla piuttosto di società gilaniche mutuali, sottolineando l’interazione tra i generi senza prevaricazione di uno sull’altro; chi ancora lega la guerra e lo Stato alla nascita dell’agricoltura stanziale e chi invece evidenzia l’esistenza di produzione agricola e società ampie e strutturate ben prima dello Stato burocratico e gerarchico promotore di guerra[22]. Il dibattito è indubbiamente complesso, ma il punto è che gli umani hanno sperimentato modi di essere e organizzarsi che esulavano dalla violenza organizzata. Altrettanto significativo è che, una volta instaurata, la guerra difficilmente scompare, poiché porta con sé una spirale di violenza traumatica che crea le condizioni per la sua replicazione.
Se la dimensione ecologica ci permette di costruire una critica della violenza sul piano ontologico (la realtà è relazionale e non frammentata), la questione della violenza di genere ci offre lo spunto per osservare quanto a fondo possa radicarsi la trasmissione di una cultura del dominio violento, tanto da risultare “naturale”. È indubbio che la maggior parte – se non la totalità – dei sistemi di dominio che studiamo nella storia umana sia di tipo patriarcale. La psichiatra Alba Arena, in coro con un gran numero di studiose, ritiene che «la prima forma organizzata e diffusa di oppressione dell’essere umano da parte di altri esseri umani sia stata l’assoggettamento delle donne ad opera degli uomini»[23]. Se il nostro mondo è intriso di guerra è anche perché ancora oggi – democrazie “più evolute” incluse – la violenza di genere è un male endemico, tassello centrale di un’educazione al dominio patriarcale che rende le nostre società posturalmente violente.
6. Interno II. Appunti sul coro
«La non violenza è l’unità interiore che si proietta in un’unità totale cosmica»[24]
Lo psichiatra Claudio Naranjo sostiene che l’ordine sociale patriarcale abbia una controparte psichica necessaria al suo perpetuarsi.
«Un aspetto di questa “mente patriarcale” […] è stata la supremazia dell’intelletto strumentale e strategico che si è avvalso della conoscenza del mondo esterno per sopravvivere e dominare, e un’altra espressione è stata l’eclissi dell’aspetto affettivo e solidaristico della mente […]. Chiamo “mente patriarcale” […] quella in cui un dispotismo intrapsichico dell’intelletto strumentale sopra la compassione e sopra il sano istinto animale (entrambi parte della nostra dotazione naturale) ci ha reso esseri freddi, insensibili e rapaci. E se ci si chiede come posso descrivere la vita civilizzata come un semplice prolungamento di tale barbarie, dirò che siamo discendenti dei barbari e che abbiamo imparato a mascherare la nostra barbarie attraverso le nostre grandi razionalizzazioni e nobili ideali»[25].
Lungi dall’essere una forza istintuale, la più pericolosa e devastante forma di violenza – la violenza organizzata – emerge come frutto di eccesso di razionalità che, tracotante nella sua pretesa di controllare e calcolare tutto, soffoca i contenuti della psiche non razionali. Ma il represso torna spesso come proiezione esterna e così il “diavolo” che soffochiamo dentro lo vediamo dappertutto fuori da noi, convinti che sia il male da debellare, giustificando la nostra violenza.
Come diceva Bateson, se è pur vero che l’immaginazione senza il rigore può portare alla follia, è altrettanto vero che il rigore senza l’immaginazione porta alla morte per paralisi. Il nostro mondo apparentemente razionale e rigoroso è paralizzato in un’emergenza ormai cementificata che non emerge mai davvero, procrastinando quindi lo stesso stato emergenziale senza arrivare mai a un punto di svolta.
Anche Jung invitava a riflettere sull’atteggiamento arrogante e pericoloso, sulla hýbris, della coscienza razionale. I gruppi umani non polarizzati sul dispotismo della ragione hanno sempre sviluppato forme culturali specifiche per far emergere i contenuti considerati irrazionali, emotivi, istintuali o inconsci e dare loro spazio e rispetto. L’enorme impianto cultuale che troviamo nella storia dell’umanità, in tutte le culture e in tutte le epoche, è la dimostrazione di quanto fosse importante e necessario non trasformare il teatro della psiche in un cabaret per monologanti. Ma il coro di voci non si adatta all’efficientismo egoico del mondo occidentale ipertecnico e iperveloce. All’espansione dominatrice coloniale esterna (in nome del cristianesimo, della scienza, della democrazia e poi del mercato), corrisponde una progressiva colonizzazione interna, dove, in un’immagine di Freud, l’Io procede bonificando le paludi dell’Es, rappresentante dei contenuti più inconsci e irrazionali.
7. Appunti sullo sfondo
tat tvam asi (tu sei ciò)[26]
Forse dovremmo sentire in modo differente la dimensione della perdita. “Perdere” etimologicamente ha a che fare con il dissipare, il mandare a male, il distruggere. Rimanda ad un gesto scelto più che a un incidente e ci offre la prospettiva della sottrazione piuttosto che dell’accumulo. Lasciare che i personaggi della nostra psiche a turno perdano il loro protagonismo, significa rinunciare al dispotismo. Concepire rituali sociali di distruzione cerimoniale delle ricchezze (il potlach studiato da Boas) o di inversione radicale dei ruoli (il naven osservato da Bateson o i Saturnali romani), permette di manifestare collettivamente il rischio dell’esasperazione delle dinamiche di dominio.
«Chi riconosce, accetta o, in determinate circostanze, favorisce una perdita non è un malato psichico. L’esperienza dello stato di lutto e del potenziale depressivo che ognuno ha in sé, ma che solo una radicale perdita o un incontro con la morte risveglia, è decisiva per la formazione del senso di responsabilità, del senso morale e del senso del limite dell’uomo maturo»[27].
Di più, forse. Attraversare la perdita ci ridimensiona: rinunciare a imporsi sull’esistenza può sintonizzarci con lo sfondo comune delle cose.
Ovviamente la soluzione non è un abbandono al caso o una rinuncia a indirizzare la propria vita e quella della collettività: si tratta però di accorgersi che come società stiamo vivendo una fase di completa sproporzione nel senso del controllo, dell’affermazione e dell’egocentrismo. Si tratta perciò di cercare qualcosa che possa riequilibrare la dinamica.
Una via per la pace implica una nuova dignità dell’idea di rinuncia, che non ha nulla a che fare con un atteggiamento di evitamento del problema o delle conflittualità. La rinuncia non è passiva, ma è la scelta consapevole di voler sottrarsi alla spirale violenta dell’interventismo, è la capacità di testimoniare la propria presenza di fronte al male senza accettare di dover riprodurre lo stesso male in nome di un valore diverso che riteniamo migliore. Implica la fiducia di non aver esaurito le possibilità umane di stare al mondo e l’onestà di dirsi che siamo in un’impasse in cui la ragione strumentale e la ragione di Stato non hanno nulla di nuovo da offrire alla Terra e ai suoi abitanti. Se abbiamo confuso il consumo col benessere e concepito l’essere in termini esclusivamente affermativi, la rinuncia è un invito a considerare i frutti ignoti di un consapevole “meno-essere”, una sorta di “decrescita antropologica”.
Più disponibili alla perdita potremmo essere più pronti a quello che Panikkar chiama “dialogo dialogale”, «che metta a fuoco qualcosa che unisca i dialoganti e che è al di fuori del loro controllo, sia conoscitivo che pratico»[28]. Questa trasformazione non può prescindere dalla riscoperta di una dimensione trascendente (la “funzione trascendente” in Jung), un terzo al di là delle parti che le include e supera allo stesso tempo, una concezione della realtà come non totalmente afferrabile, non-dualista e sempre eccedente.
Panikkar ribalta l’idea di filosofia: non tanto “amore per la sapienza”, ma “sapienza dell’amore”, non inteso ovviamente come semplice bontà, ma come apertura radicale all’alterità, come postura che rinuncia all’acquisizione e allena la fiducia nello sfondo comune.
Una realtà ecologica è, di per sé, una realtà non-violenta e profondamente amante. Come per il dovere degli stoici, l’educazione all’amore è un gesto di armonia con la realtà.
Ciò non significa che non esista la violenza: forse però, essa è prima di tutto una dimensione originaria, dove l’individualizzazione è già in qualche modo una forma di separazione rispetto alla trama della vita universale. Come nota il filosofo e storico delle religioni Terrin, la violenza «è lo specchio della prima opposizione all’interno della totalità. È la rivalsa del principio di differenza rispetto al principio di identità»[29]. È in qualche modo imprescindibile, ma come elemento che permette la stessa vita cosciente dell’umano. E dopo, cosa succede?
Le culture umane hanno intrapreso strade diverse: il mondo semitico ha legato il “sacro” – e quindi l’aspetto più profondo della realtà – alla separazione (da cui il sacer latino di cui ha scritto Agamben) strutturando una prospettiva dualista (il sacro e il profano; il puro e l’impuro; la divinità e l’umanità); quello indoeuropeo, invece, ha intrapreso la via dell’interezza, proponendo una visione e una percezione della realtà non-dualista (l’advaita indiana, la non totale separazione tra l’Ātman individuale e il Brahman universale).
Nel primo caso emerge uno scarto netto e, secondo Terrin, sarà necessaria un’altra violenza per ritornare all’unità: detta banalmente, niente paradiso senza morte. Nel secondo prevale la continuità, il fatto che la violenza originaria non è così brutale e non ha strappato nettamente le parti. L’immagine è quella delle onde che per essere tali non devono staccarsi dall’oceano. L’unità non si è mai persa davvero e la consapevolezza è la via per riconoscerlo, per mostrare una non-violenza di fondo, l’Ahiṃsā di cui Gandhi si è fatto portatore.
E se sottraendoci al nostro riduzionismo antropo- ed egocentrico smettessimo almeno per un attimo di vedere la vita dai nostri occhi e riuscissimo a vedere noi stessi con gli occhi della vita? Cosa succederebbe dopo?
Gandhi veniva detto satyāgraha, ovvero colui che si fa portatore di non-violenza poiché tende alla verità (satya). «L’obbligo di non ferire il vivente, l’obbligo verso la verità: venivano detti insieme, e ahiṃsā precedeva satya, come se nel fondo dell’una parola si rivelasse l’altra»[30]. La verità è l’unità di fondo, la relazionalità del Tutto.
All’origine di quella che consideriamo la nostra filosofia, Anassimandro ci lascia un frammento a cui il grande filosofo Giorgio Colli dà molta importanza. «Le cose che sono, difatti, subiscono l’una dall’altra punizione e vendetta per la loro ingiustizia»[31], per il loro aver ferito la realtà ed essere divenute qualcosa. Commenta Colli: «La nostra vita, l’individuazione, è un’ingiustizia di fronte alla primordiale unità divina, da cui viene riassorbita. […] in realtà l’ingiustizia non è commessa contro l’unità divina, bensì è qualcosa che appartiene al nostro mondo, è la “volontà di potenza” che lo fa sorgere e perire; […] e tutta la nostra vita non è causata dalla divinità; ma è un distaccarsi dalla divinità primordiale»[32]. Ma anche lì, forse, la ferita non è un taglio netto, piuttosto un temporaneo e parziale allontanamento.
Che cosa c’entra tutto questo con la violenza e la guerra? Se riconoscessimo questa violenza originaria, se la sentissimo dentro di noi e comprendessimo se e come interagisce con al nostra aggressività, frustrazione, con la nostra fortezza egocentrica e con la nostra debolezza; se la ammettessimo anziché rimuoverla completamente, forse cambierebbe il nostro modo di agire e di essere. La violenza diffusa e strutturale del nostro mondo ipermoderno non potrebbe essere anche frutto di una grande assenza di consapevolezza rispetto ad una violenza originaria insita nella vita stessa? Non potrebbe essere l’ombra che la luce gloriosa del mondo secolarizzato proietta senza davvero rendersene conto?
Che relazione c’è tra la guerra in noi e la guerra là fuori?
Note:
[1] Fernando Pessoa, Poesie di Fernando Pessoa, Adelphi, 2013, p.157.
[2] Guy Debord, La società dello spettacolo, De Donato editore, 1968, p.11.
[3] Chandra Livia Candiani, Il silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione, Einaudi, 2018, p.75.
[4] Pierre Vidal-Naquet, Il mondo di Omero, Donzelli, 2001, p. 31.
[5] Ivi, pp. 31-32
[6] Una delle frasi del tempio di Apollo a Delfi che invita a riconoscere l’importanza e il senso del limite.
[7] Chandra Livia Candiani, Il silenzio è cosa viva, Einaudi, 2018, p. 84.
[8] Marc Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi, 1969, p. 163.
[9] Luigi Zoja, Storia dell’arroganza. Psicologia e limiti dello sviluppo, Moretti & Vitali, 2003, p. 208.
[10] Chuang-tzu, La calma, Mondadori, 2007, in Chandra Livia Candiani, Il silenzio è cosa viva, Einaudi, 2018, p. 25.
[11] Luigi Zoja, Storia dell’arroganza, Moretti & Vitali, 2003, p. 207.
[12] Arne Næss, Introduzione all’ecologia, Edizioni ETS, 2015, p. 26.
[13] Si veda Raimon Panikkar, La torre di Babele. Pace e pluralismo, Cultura della pace, 1990.
[14] Si veda Giuseppe Cognetti, La pace è un’utopia? La prospettiva di Raimon Panikkar, Rubbettino, 2006.
[15] Giuseppe Cognetti, op. cit., p. 108.
[16] Per una sintesi di alcune prospettive si veda Carlo Perazzo, In comune. Nessi per un’antropologia ecologia, Castelvecchi, 2023.
[17] Si veda un’intervista all’antropologo in https://www.pressenza.com/it/2021/02/la-tendenza-a-fare-la-guerra-non-e-innata-nelluomo-intervista-allantropologo-brian-ferguson/
[18] Ibidem.
[19] Ibidem.
[20] Ibidem.
[21] Ibidem.
[22] Si veda Alessandro Baccarin, L’origine senza origini della civiltà, in «Altraparola», L’immateriale e il corporeo, N. 7, giugno 2022; Alba Arena, La barbarie silenziosa. La violenza contro le donne e la crisi del patriarcato, Edizioni Clandestine, 2014.
[23] Alba Arena, La barbarie silenziosa. La violenza contro le donne e la crisi del patriarcato, Edizioni Clandestine, 2014, p. 11
[24] Aldo Natale Terrin, Il respiro religioso dell’Oriente, EDB, 1997, p. 54.
[25] Claudio Naranjo, Por una economìa humanista, in Alba Arena, op. cit., p. 33.
[26] Chāndogya Upanishad.
[27] Luigi Zoja, Storia dell’arroganza, Moretti & Vitali, 2003, pp. 207- 208
[28] Giuseppe Cognetti, La pace è un’utopia? La prospettiva di Raimon Panikkar, Rubettino, 2006, p. 40.
[29] Aldo Natale Terrin, Il respiro religioso dell’Oriente, EDB, 1997, p. 52.
[30] Roberto Calasso, Ka, Adelphi, 1999, p. 181
[31] Giorgio Colli, La sapienza greca II, Adelphi, 1992.
[32] Ibidem.